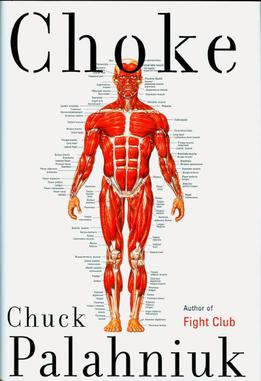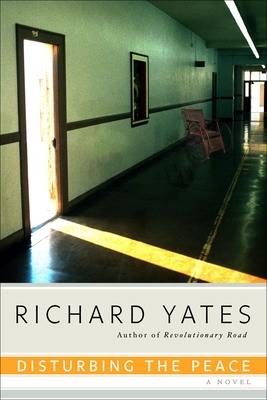Le Fantastiche Avventure di Kavalier e Clay _letture


Avevo sentito parlare molto bene di questo romanzone di Michael Chabon e non ho potuto che verificare se le voci entusiastiche di tanti lettori su Anobii fossero fondate o meno. Che dire? Bello è bello, ma non si tratta certo del capolavoro di cui alcuni hanno scritto e forse anche il Pulitzer vinto non è poi chissà quanto meritato. E' un romanzo profondamente americano, ecco, questo deve aver influito per forza. Progressista, ottimista, politically correct, anche sottilmente retorico come tanti prodotti letterari (e non) made in U.S.A.. Al di là di questo limite, l'ironia dell'autore si è rivelata assai piacevole come la sua scrittura molto naturale, forbita senza risultare saccente. E' estremamente accurato Chabon nel raccontare una realtà scintillante da lui non vissuta, anche se non si può dire altrettanto per la resa psicologica dei suoi amati personaggi: un po' troppo superficiali, un po' sbrigativi, come si trattasse anche in questo caso di veloci abbozzi su carta, disegnati in maniera grezza e poi ripassati a china. Si legge comunque volentieri, e forse è questo ciò che conta, perché dice cose non banali sul più grande dramma del novecento e sulla guerra in genere, ma lo fa con garbo e senza appiattirsi su una vuota prospettiva pietista. Un romanzo d'avventura, anche, e di costume, di quelli che dovrebbero essere divorati. Stranamente io non ci sono riuscito, procedendo con lentezza (ma senza vera noia) tranne che in alcuni frangenti più esaltanti. In ogni caso, consigliato.
Ha ragione chi ha definito ‘The Amazing Adventures of Kavalier & Clay’ il “romanzo della fuga”, anche se sarebbe forse più corretto completare la formula parlando di fuga negata, o impossibile, dall’inesorabile sventura del divenire adulti. Chabon dissemina di infiniti rimandi al concetto di evasione le oltre ottocento pagine di questo libro, a partire dall’incontro in cui i due protagonisti – i cugini citati nel titolo – si scoprono motivati da un comune desiderio di diserzione dal presente e realizzano di poter diventare i migliori alleati l’uno dell’altro nella direzione dei propri sogni. Sam “Sammy” Clay l’indole del sognatore ce l’ha da sempre, da quando abbandonato in tenera età da un padre celebre e scellerato, “tutto muscoli e niente cuore”, iniziò a coltivare propositi infantili di riscatto nei panni del grande romanziere americano, del critico geniale o del medico eroico, allenandosi sin da giovanissimo a mentire spudoratamente come riflesso dell’aspirazione a diventare qualcuno di molto diverso. Joseph “Joe” Kavalier, esule da una Cecoslovacchia ormai caduta sotto gli artigli della Germania Nazista, è al contrario sicuro del proprio talento, estroverso e competente, anche se ha non meno ragioni del cugino per aggrapparsi con forza ad un mondo più roseo di quello reale, una sceneggiatura orchestrata dal potere dell’immaginazione per sancire il trionfo incontrastato di giustizia e libertà. Messi alla prova da una coppia di avidi editori, Sammy e Joe trasformano da subito in qualcosa di vincente il loro sodalizio, inventando dal nulla un nuovo supereroe dei comics, l’Escapista, personaggio armonioso destinato a fare concorrenza a Superman in qualità di liberatore degli oppressi. Ovviamente dietro l’artificio della fiction c’è la dura realtà di chi come Joe ha davvero studiato da fuggiasco: gli anni del suo apprendistato escapista a Praga presso il vecchio Kornblum, ebreo lituano maestro illusionista e seguace di Houdini, sono ampiamente trattati dall’autore in pagine ricche di fascino e sinceramente commoventi. Un po’ come quelle in cui è raccontata la genesi dell’eroe disegnato a china, a dire il vero forse un po’ troppo lunghe ed infarcite di dettagli marginali: la febbrile materializzazione del sogno dei due ragazzi e le iperboliche fantasie del fumetto da loro ideato sono piani che si intersecano compenetrandosi, contaminandosi grazie alla prosa leggera ma brillante di Chabon, dando forma ad un universo nuovo fatto di confini incerti, illusori, eppure assai intrigante: “la nostra, se posso dirlo, è una fottutissima bella storia!”. E’ a questo punto che il personaggio di Joe ruba letteralmente la scena a tutti gli altri. Il suo passato, più drammatico e movimentato, si riflette inesorabilmente su un presente divenuto prestissimo un’autentica missione. Disegnare le storie violente dell’invincibile nemico dei nazisti è il solo mezzo per combattere con un certo costrutto la propria guerra personale: legittimare la libertà conquistata grazie ad una fortuna mancata ad altri – primo tra tutti l’adorato fratello minore Thomas – stimolare nei giovani americani del 1939 l’odio per Hitler e, almeno tra le pagine dei fumetti, sconfiggere il mostro e vendicarsi. I soldi ed il successo arrivano (anche se in misura minore rispetto agli effettivi meriti) ma Joe non trova pace. A New York non si sente a casa pur essendo grato per tutte le opportunità ricevute e fatte fruttare. Soffre per quella condizione di esule impotente, lontano da una famiglia destinata all’annientamento, che lo condurrà sull’orlo di un baratro emotivo e materiale. L’amore per la ricca e bella Rosa Saks, pittrice e spirito libero incontrata grazie ad un gioco benevolo del destino, segna una svolta. Senza annullare l’orgoglio che lo ha sempre visto irriducibile di fronte alle richieste di autocensura dei suoi editori (“Io credo nel potere della mia immaginazione!”) per non tradire gli ideali che hanno animato tutto il suo lavoro, Joe e la sua arte si fanno più disciplinati e concreti. Da strumento di una sterile vendetta rivolta a nemici troppo lontani o troppo insignificanti, i fumetti possono trasformarsi in qualcosa di più costruttivo, qualcosa di prezioso per esprimere fino in fondo se stesso e le proprie aspirazioni. Il cuore di Kavalier sembra riuscire finalmente ad uscire dal caos, anche grazie al progetto, ormai quasi in porto, di salvare Thomas e tanti altri bambini ebrei dagli orrori della guerra e da morte pressoché certa. La fatalità si impone comunque e rimescola tutte le carte, definendo una brusca sterzata negli eventi narrati. Chabon è limpidissimo nei confronti del lettore. Sin dalle pagine dei trascorsi praghesi di Kavalier è prodigo nell’affabulare ma lascia comunque intuire che piega prenderanno gli avvenimenti, trattenendo quasi confuso sullo sfondo un senso di morte e di ineluttabilità che è ben presente pur restando nella sfera del non detto, rispettoso silenzio di fronte alla tragedia di tutto il popolo ebraico. Reso cieco dall’odio e partito per combattere, Joe è protagonista di un plateale ritorno in scena dopo una serie di avventure picaresche ed una fuga non meno monumentale da tutto e tutti (un ellissi durata anni, spesi come un’ombra divorata dal rimorso e dalla vergogna), in un finale positivo all’insegna del ricongiungimento, forse sin troppo accomodante.
Cosa aggiungere a proposito di questo colossale romanzo vecchio stampo? E’ un libro che prende, senza dubbio, un libro sicuramente molto bello cui è difficile non affezionarsi. Non è un capolavoro. Forse conquista più che altro per la disinvoltura descrittiva con cui Chabon tratteggia l’America ormai prossima alla seconda guerra mondiale, il 1941 di ‘Citizen Kane’, delle feste con Dalì e di Pearl Harbour. Una miriade i riferimenti culturali (alti e non) che stordiscono ed affascinano, imponendosi in fin dei conti anche sulle vicende narrate e sui protagonisti. Un trionfo per la funzione referenziale e per il contesto, segno di qualità straordinarie di cronachista ed illustratore, a scapito però del narratore. Certo ‘The Amazing Adventures of Kavalier & Clay’ non è comunque un libro noioso, niente affatto, ma rivela un autore spesso troppo affezionato al mondo raccontato, troppo incline a soffermarsi sul pur entusiasmante inessenziale per poter colpire realmente al cuore. Cosa che accade, comunque, anche se quasi esclusivamente nelle pagine della rocambolesca fuga di Kavalier assieme al mitico Golem di Praga, oltre a quelle della sua vera guerra nella crudele alienazione dell’antartide; momenti, questi, incredibilmente appassionanti, con il protagonista messo finalmente a nudo, svuotato dal desiderio di assoluta vendetta al cospetto del quale tutto finisce col perdere senso: l’arte, l’affetto, l’amicizia e perfino la pietà (memorabile l’episodio della morte del cane Oyster). Il libro funziona egregiamente come celebrazione dell’età dell’oro dei fumetti, come atto d’amore incondizionato verso i comics in generale, ribaltando a loro esclusivo merito la logora accusa secondo la quale essi offrirebbero “solo” una facile fuga (ancora) dalla realtà. Non altrettanto memorabile il lavoro sui personaggi, sviluppati ed approfonditi meno del dovuto come fossero proprio eroi di quell’arte a torto considerata minore. In confronto all’eccezionalità (romanzesca) e allo spessore (apparente) di un personaggio “pieno” come Joe Kavalier, tagliato con l’accetta ma ugualmente sfuggente, Sammy Clay può apparire pallido, normale, convenzionalmente impostato, eppure moderno e pirandelliano (dove Joe è più “all’antica”, vero eroe da romanzo d’avventura): reduce in fuga (ancora, sì) da un’irrisolta relazione omosessuale, è chiamato ad incarnare la mediocrità di chi è sempre e comunque presente, maturo e responsabile, “incatenato al mondo in modo irrevocabile”. Emblematico per un attore infelicemente incompiuto come questo è il romanzo autobiografico “La Disillusione Americana”, mastodontica tela di Penelope da lui sempre ripresa e sempre abbandonata, simbolo forse facile ma efficace: “un po’ commedia amara, un po’ stoica tragedia alla Hemingway, l’autobiografia di un uomo che non sapeva porsi di fronte a se stesso, un intreccio complicato di stratagemmi e bugie senza la capacità artistica di trasmettere, anche inconsapevolmente, la propria realtà”. Se Sam convince quindi in generale più di Joe, è ottima in questo quadro la figura crepuscolare del suo implicito mentore Deasey, colui che lo aiuta a diventare consapevole dei propri mezzi in un mondo di profittatori e ad aprire gli occhi sul mesto ma inevitabile fallimento di ogni talento letterario. Talento che a Chabon è valso il Pulitzer e che in ‘The Amazing Adventures of Kavalier & Clay’ è stato espresso con ogni probabilità al massimo delle proprie potenzialità visionarie.