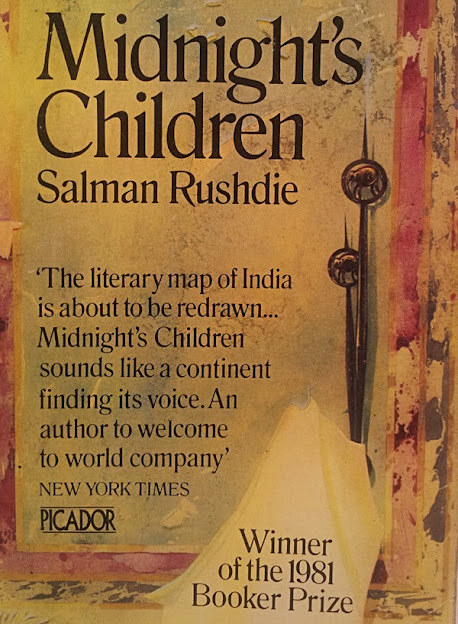Una Banda di Idioti _Letture
Mi stanno facendo penare parecchio le Poste Italiane, magari in combutta con l’ufficio posta aziendale, per farmi avere tra le mani un testo che ho acquistato su ebay in virtù di un prezzo più che vantaggioso e di condizioni generali prossime alla perfezione dei manufatti intonsi. “Neon Bible” si intitola, come l’album degli Arcade Fire (che, ovvio, proprio ad esso si sono ispirati). “La Bibbia al Neon”, opera prima di uno scrittore giovane e folle morto suicida a soli trentuno anni. Certo chi cercasse in giro informazioni sul suo conto troverebbe ben pochi riferimenti su questo libro d’esordio scritto all’età di sedici anni, visto che John Kennedy Toole è noto quasi esclusivamente per aver partorito un’altra opera (sua seconda e ultima), “A Confederacy of Dunces”, “Una Banda d’Idioti”. Visti i commenti su Anobii e la significativa diffusione del romanzo anche in Italia, citato un po’ ovunque alla stregua di un autentico Cult Book (inevitabile quando un testo che tutti gli editori si rifiutavano di pubblicare perché “non parla di niente” si aggiudica il Pulitzer postumo, a undici anni dalla morte che il suo autore si diede per la delusione), mi aspettavo una sorta di irrinunciabile capolavoro. Non è andata esattamente così, anche se penso di riuscire a intuire le ragioni di questa spropositata venerazione. E’ un’opera apparentemente sconclusionata e grottesca come il suo titanico protagonista – autobiografico in tutto e per tutto – ma porta in sé i germi di tante rivoluzioni che ai tempi in cui venne scritto erano ancora lungi dal manifestarsi: lo spirito del sessantotto, per esempio, o l’irriverenza dei giovani a caccia di un mondo diverso, più aperto e meno gretto. E soprattutto l’irrancidirsi del sogno americano, un processo incarnato con straordinaria modernità proprio da Ignatius Reilly e dal suo plateale disincanto. I grandi meriti del romanzo risiedono quindi in questa sua carica, dissacrante e anticipatoria di tante tendenze e di tanto attuale nichilismo. Al di là di questo, “Una Banda di Idioti” resta un libro divertente e curioso ma non certo esaltante. Chiuso il discorso (segue recensione), dall’opera prima “Una Bibbia al Neon” – che questo alone mitico non se lo porta dietro nonostante l’adozione da parte di una delle band più osannate del pianeta (escludete tranquillamente il sottoscritto) – non saprei proprio cosa aspettarmi. Sarebbe già una gran cosa (sarebbe già qualcosa) se a dodici giorni dalla spedizione mi arrivasse finalmente tra le mie mani.
In una New Orleans assai poco cinematografica e ridotta a sgangherato teatro dell’assurdo, il trentenne Ignatius Reilly è una sorta di solitario partigiano in una guerra di resistenza contro il cattivo gusto e la mancanza “di teologia e geometria” negli esseri umani, giunta evidentemente alle sue battute conclusive. Ragiona e si muove come sull’orlo di un baratro, elevandosi a baluardo ultimo di una morale di suo alquanto contraddittoria, messa costantemente a dura prova da un progresso bugiardo, dalle perversità di un ottimismo generalizzato e dalla crescente libertà sessuale e nei costumi che, ai suoi occhi gialli e blu pieni d’alterigia, appare come irrefrenabile e perniciosa licenziosità senza freni inibitori.
Il rubicondo Ignatius ci viene presentato sin dalle prime pagine come un pazzo furioso. E’ chiaramente un soggetto moralista, reazionario, bigotto, onanista, indisponente, viziato e infantile. Un paranoide sociopatico, abbigliato in modo pratico e confortevole quanto grottesco, convinto che la sua folle ed “eroica” Weltanschauung instilli odio e paura negli altri (“Sono un anacronismo vivente. Questo la gente lo capisce e mi diventa ostile”) spingendoli a fare comunella contro di lui. In libertà nella sua testa si agitano come spettri senza requie pensieri deliranti, frutto di un’intelligenza fervida e assai poco convenzionale. Nonostante l’aspetto gretto e volgare, Ignatius è infatti anche una persona colta che ha scelto di laurearsi con tutta calma, coltiva aspirazioni da grande scrittore e si sta faticosamente dedicando alla stesura di un interminabile pamphlet, sconclusionato trattato di storia comparata elogio del Medioevo più fosco e violento atto d’accusa “contro il nostro secolo” e l’illuminismo, esorcizzato come simbolo di un mondo barbaro e considerato l’origine di tutti i mali moderni.
Le sue ambizioni sono alte, smisurate: vorrebbe emulare l’eremitaggio del poeta Milton come espediente per una perfetta meditazione e per l’autoperfezionamento nell’arte dello scrivere e riporta in calce ai suoi farneticanti scritti massime solenni di Platone come dediche ai suoi inesistenti lettori. L’ossessione per la Rota Fortunae sembra condizionare ogni sua scelta mentre il De Consolatione Philosophiae è la stella polare della quale si serve per orientarsi nelle anse di una squilibrata relazione con l’anziana madre alcolizzata ma anche in una New Orleans degradata a “capitale del vizio del mondo civilizzato”, rifugio di “puttane, esibizionisti, alcolizzati, sodomiti, tossicomani, feticisti, pornografi, truffatori, megere, inquinatori e lesbiche” dalle cui avvilenti paludi non ha modo di evadere per via di una cronica fobia per i pullman granturismo. Toole ce lo presenta dapprima nel chiuso delle quattro mura domestiche, come un sudicio dittatore che trova sempre da ridire o puntualizzare su tutto, pur difettando di esperienza in ogni campo, si ingozza di porcherie come un bambino e limita i suoi contributi in casa a qualche spolverata e alla crema al formaggio, sua unica specialità in cucina. L’ideale isolamento resta tuttavia una sua chimera visto che il (non più tanto) giovane Reilly coltiva – apparentemente controvoglia – una relazione epistolare con la sua ex fidanzata Myrna Minkoff, turbolenta idealista fuggita a New York, ed è costretto a cercarsi un lavoro per aiutare la genitrice a ripagare un pesante debito contratto in seguito a un incidente automobilistico. Una bella rassegna di tragicomiche avventure occorsegli dapprima nei panni dell’archivista-parassita presso le fallimentari Manifatture Levy, quindi in quelli ben più degradanti di venditore di hot-dog nelle strade del pittoresco quartiere francese, segneranno il suo esplosivo scontro con la realtà. Da innocuo teorizzatore della scaltrezza improduttiva e dell’assenteismo a agitatore per i diritti degli operai afroamericani e promotore di una diabolica campagna pacifista alla guida delle masse omosessuali, il Nostro piccolo genio incompreso finirà col diventare un’inconsapevole pedina nel più ampio quadro del malaffare cittadino e sarà costretto a optare per una fuga rocambolesca quanto miracolosa dalle proprie più ataviche paure e da un sicuro internamento.
Un’elettrizzante inclinazione per il nonsense e un debordante humour surrealista esercitato a tutto campo restano la linfa fondamentale di questo romanzo pirotecnico e volutamente malsano, nei ragionamenti maniacali di Ignatius ma anche e soprattutto nelle situazioni al limite della farsa in cui il grasso e baffuto antieroe si trova perennemente calamitato, nonché in tutta una serie di deliziose figurine di contorno, determinanti nel garantire poco alla volta un senso alla presunta insensatezza nelle riflessioni del grande protagonista di questo libro. Capita così di imbattersi in una madre, Irene, in cerca di evasioni giovaniliste evidentemente fuori tempo massimo; in un agente, Mancuso, perennemente vessato dai suoi superiori e costretto a lavorare in condizioni via via più degradanti e sotto ridicoli camuffamenti; in un imprenditore, Gus Levy, del tutto disinteressato agli affari fino ad un insperato ravvedimento; in un’ottuagenaria rimbambita, la signorina Trixie, costretta a veder prorogato a oltranza il proprio pensionamento come se questo fosse un favore che le viene riservato; in un capoufficio disgraziato, Gonzalez, che scambia i fannulloni per prodigi e vive con terrore l’inesistente autorità del suo superiore; nella proprietaria dell’immondo “Notti di Follia”, Lana Lee, che pare più una maitresse avida e schiavista che non una semplice commerciante. Di questo “Una Banda di Idioti” è particolarmente interessante la struttura discontinua che segue in parallelo diverse tracce privilegiando le bizzarre esperienze di Ignatius e quelle del filosofeggiante e bistrattato inserviente Burma Jones, destinate a convergere e incrociarsi in una frenetica serata al “Notti di Follia” in cui tutto sembrerà precipitare, salvo dar luogo poi a un’impensabile svolta per ciascuno dei personaggi in scena. Il lettore è coinvolto attivamente e l’interpretazione riserva sorprese man mano che si procede: si sarebbe dapprima portati a credere che lo sgradevole Ignatius sia l’unico folle in un mondo non bello ma popolato da savi. Pian piano si riconoscono tuttavia manie e segni di squilibrio in ogni caratterista chiamato da Toole a recitare nei tanti ruoli di secondo piano, e per ognuno di loro la prima impressione andrà inesorabilmente incontro a un beffardo rovesciamento. E’ curioso poi come il finale, con la salvezza offerta a Reilly proprio da quella Myrna Minkoff che ci era stata presentata fino a un attimo prima come la causa di ogni suo male, segni l’ultimo e più assurdo ribaltamento: con il prorompente ritorno di una ragione prima annebbiata, sembra proprio che l’ingombrante antieroe fosse davvero soltanto la vittima di una serie di sfortunati eventi nell’opprimente recinto urbano animato da tanti pazzi scatenati.
Nelle pagine di “A Confederacy of Dunces” c’è la vecchia America gretta, conformista, ipocrita e xenofoba dei conflitti razziali e di classe. Più sullo sfondo, nelle lettere di Myrna al protagonista, si intravedono i germi del femminismo e della contestazione giovanile degli anni ’60 (il testo è del 1963 anche se venne pubblicato postumo solo nel 1980). E poi c’è il capolavoro autobiografico rappresentato da Ignatius, che si presenta come guida filosofica alla stregua di Severino Boezio per la Roma corrotta e decadente del suo secolo e nella sua pigrizia e nel suo disincanto nichilista (memorabile il motto boeziano stravolto “Il lottare è in fin dei conti privo di senso, ed è meglio rassegnarsi”) è ben oltre, già alla fine di qualsivoglia utopia, egoista e asociale eppure schiavo della necessità di aprirsi proprio come la sua dannatissima valvola pilorica. Nel clima da basso impero del romanzo, preannuncia con largo anticipo il deterioramento dell’American Dream e risplende quindi come un personaggio attuale in maniera perfino sconcertante. Curioso come i due attori scelti con lungimiranza per gli adattamenti cinematografici del libro – John Belushi prima e John Candy poi (il protagonista di “Un Biglietto in Due” sembra fisicamente tracopiato dal testo) – siano morti entrambi prima del tempo facendo naufragare i rispettivi progetti. E proprio la morte giovane (e da suicida) dell’autore, John Kennedy Toole, non può non aver pesato nel promuovere il romanzo, forse oltre i suoi effettivi meriti, al rango di Cult Book e alla vittoria del Pulitzer per la narrativa. Non si tratta di un capolavoro, come si legge scritto ovunque da schiere di entusiasti ammiratori, ma resta comunque una lettura assai piacevole e intelligente.