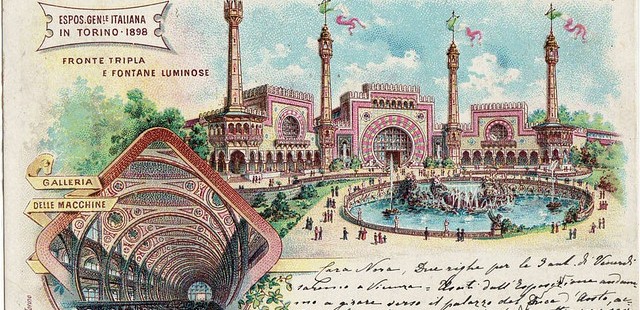Oh anima mia, fa’ che io sia in te adesso
Guarda attraverso i miei occhi, guarda le cose che hai creato
Tutto risplende
Per anni è stata sufficiente l’illusione, promossa come più facile delle imbeccate da quella figura così austera. Gonna a strascico, scialli e camicette nere, lunghi capelli di corvo raccolti in uno chignon.
E lo sguardo dall’inconfondibile ombra triste, sempre enigmatico nella sua gravità.
Ovunque la riconoscevi come il fantasma di Emily Dickinson, persa in un passato astratto ed impossibile.
I frammenti malinconici della sua antologia folk claustrale, compilata con ascetico riguardo sulle liriche della poetessa di Ahmerst, non potevano che rappresentare il fondo di questo esorcismo, quasi una liberazione. Nelle altre riletture quel senso di possessione mancava. Niente abbaglio mesmerico dentro le canzoni, anche se coraggio e finezza antiaccademica sono sempre stati insopprimibili prerogative per la sua sensibilità di artista. Così i lieder della tradizione romantica tedesca trasfigurati in ‘A Wolf in Sheep’s Clothing’ dai fuochi bianchi e acidi delle chitarre elettriche, così il canzoniere popolare di Garcia Lorca tonificato in ‘Anda Jaleo’ dal cristallo del charango e da una vivida asprezza gitana esercitata a tutto campo.
Esaurito lo slancio di questa sua parentesi devozionale, Josephine Foster torna a vestire i panni della strega campestre degli esordi, quando lo standard appalachiano delle sue composizioni per ukulele era traviato dalla vitalità selvatica di un’affilata ma irrequieta vena psichedelica. Soltanto una sfaccettatura tra le altre per quella voce incredibile, un soprano salmodiante forgiato in ambito lirico e sorpreso nell’imbarazzo tra inclinazioni lugubri e ridenti arabeschi, smussatura palese dei tanti anni spesi a perfezionarsi tra funerali e sposalizi.
Appena pubblicata la seconda raccolta iberica, Josephine ha abbandonato il suo rifugio andaluso per tornare in patria e registrare il nuovo ‘Blood Rushing’, disco che rilascia uno sfacciato aroma di States sin dall’inequivocabile allegoria della copertina, personale rivisitazione pittorica della propria bandiera nazionale. Il sottile filo rosso che lega campi e firmamento è lo scorrere impetuoso di un sangue – o di un vino, stando all’incalzante ritornello di ‘O Stars’ – che è l’essenza stessa della natura orgogliosa ed indomabile. Il Rio Colorado dei remoti esploratori spagnoli si tuffa dal Grande Carro a battezzare una nazione e ad ancorarla a quanto ha di più sacro. Non soltanto il sole, oggetto di una benedizione sincera in una luminosa mattina d’inverno. Non solo il vento, che sferza indifferente le mille torri di Chicago. Non solo gli affacci vertiginosi sulle Rocky Mountains, o le colture vezzeggiate nella febbre di un canto propiziatorio. Tutto il quadro insieme, l’intero patrimonio. Anche la pancia gassosa della terra, anche la limpidezza feconda dell’acqua, lo scintillio benevolo delle stelle.
Blushing è il doppio in scena e la guida, colei che arrossisce, che presta occhi e cuore sul sentiero. E’ suo il diario che sfogliamo, miniature tonali e annotazioni di un misticismo astrale. Un compendio bucolico che ricorda la spensierata Arcadia di Vashti Bunyan, ma con ambientazioni e corredo simbolico profondamente americani. Un sigillo evidente nella piega populista di certe ballate, alt-country che non disdegna rigogli gospel e riscatta la maggiore prevedibilità della scrittura con tutta la classe ed il polso della cantante, oltre magari ai pregevoli orpelli flessuosi della sua chitarra. Al solito il picking nudo si apre ad un florilegio di digressioni. Stilizza fino all’osso ma non rinuncia ad aggraziare l’ordito con suggestioni arcane quanto inattese, rendendo movimentato e a tratti perfino eccentrico un album, per altri versi, dalla perentoria impronta classicista. Semplice e semplicemente arrangiata ma del tutto accattivante, la cavalcata di ‘Sacred Is the Star’ è il manifesto emblematico di questo inedito approccio easy listening: folk melodioso e zampettante, refrain killer in una dotazione di pelli e mandolini, carta di libera cittadinanza per le orecchie di ogni ascoltatore. Anche rallentando i giri e curando più a fondo la foggia dei ricami, la scrittura si conferma penetrante e disinvolta.
Naturale e suadente Josephine, eppure impervia. Sfuggente quando al momento del congedo sceglie di far bisticciare country-blues e psych-folk e va a bersaglio per franchezza innata.
‘Blood Rushing’ è la sua improvvisa colica pop.
Svolazzante. Ambigua.
Nervosa, eterea, lussureggiante.
Fragile come le Electrelane auliche e commoventi dell’addio. Pure pietrosa. Eruttiva ed arrembante nel suo vestitino avant-folk, a briglie sciolte in poche sfuriate elettriche come riusciva ai Gorky’s Zygotic Mynci in piena sbornia da crapule rock. Oppure esile e silvana in quella mise da maliarda à la Joanna Newsom, che dai tempi della New Weird America le è sempre calzata a meraviglia.
La Foster di oggi è un quarzo opalescente. Una maestra di incantesimi, di fascinazioni raminghe. La sirena che intesse delicate ninnananne per un mondo spogliato di ogni armonia. E proprio come Emily nella sua stanza, continuerà ad irretirci nella perfezione silenziosa della nostra solitudine.