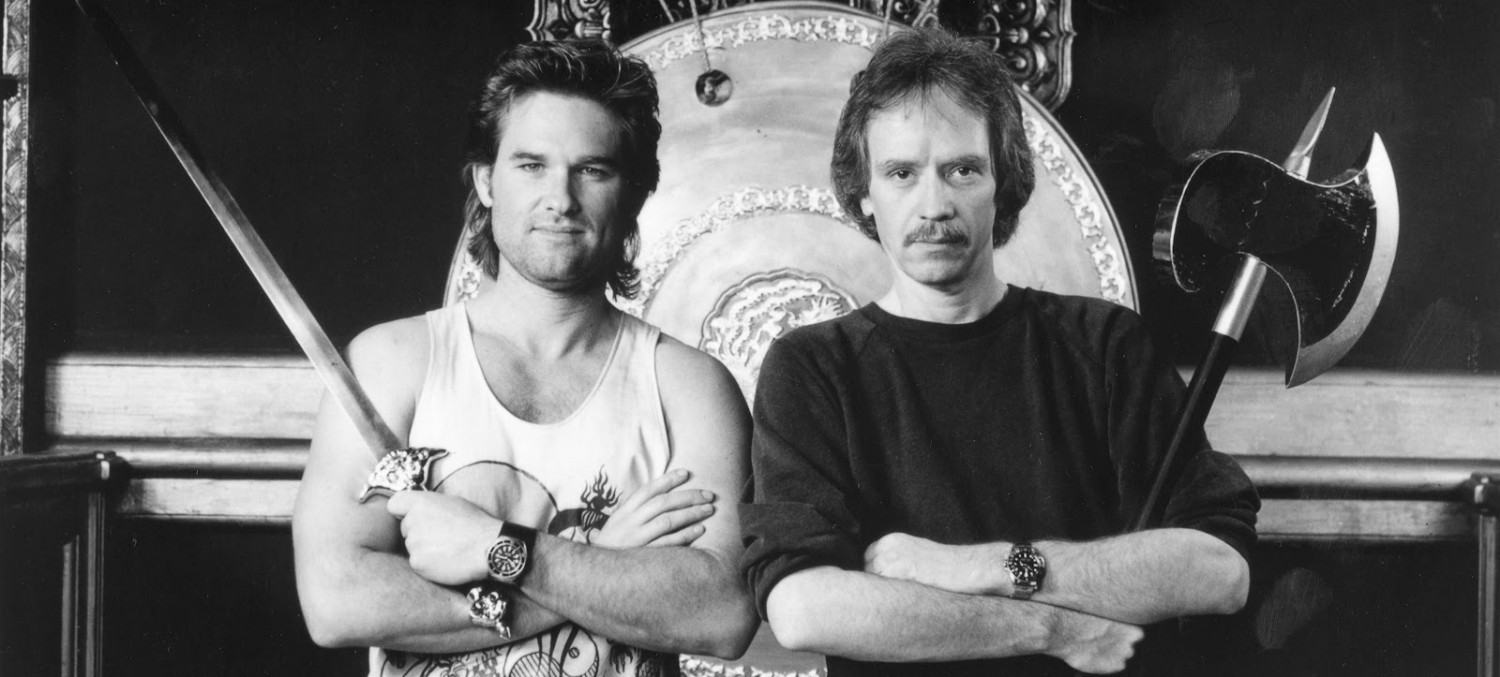Stoner _Letture
Più di cinque anni che non entravo qui dentro. Un lustro abbondante in cui sono stato impegnato da una seconda parentesi universitaria che ha tolto praticamente ogni spazio alla scrittura, alla musica e, sì, anche alle letture. Ora che quel vortice di impegni full time è definitivamente passato, lasciando evidenti macerie tutt’attorno, non ho potuto esimermi dal tornare a leggere qualcosa che non fossero i manuali di pedagogia o psicologia dell’età evolutiva, con un accanimento se possibile maggiore rispetto al passato. I primi titoli affrontati, è vero, sono ancora legati a questa fase prossima all’epilogo con la tesi di laurea, anche se letture (o ri-letture) come “Pinocchio”, “Il giornalino di Gian Burrasca”, “Giannettino”, “Ciuffettino”, “Viperetta”, “Sussi e Biribissi”, “Le pìstole d’Omero”, restano senza dubbio piacevolissime. Stesso discorso per il Céline insperato di “Guerra” – che è stato un po’ come ritrovare un vecchio amico figlio d’un cane – e in parte con “Sulla strada” di Kerouac, uno di quei nomi famosi e mai letti che tenevo lì da qualche secolo senza aspettarmi nulla di ché, ma che in realtà si è rivelato piuttosto buono e, soprattutto, invecchiato davvero bene. Per il prosieguo, tra i titoli messi in valigia spiccava questo benedetto “Stoner”, acquistato esattamente nell’estate di dieci anni fa sull’onda di tutta una serie di recensioni entusiastiche. Fazi lo aveva da poco rilanciato, cogliendo con grande opportunismo la relativa riscoperta in mezzo mondo di un’opera assai poco fortunata, ai tempi della pubblicazione, per un autore in seguito capace di vincere il prestigioso National Book Awards per la narrativa con “Augustus”. Da allora ho visto scorrere sui social un buon numero di commenti a cinque stelle, ora lapidari per eccesso di folgorazione, ora minuziosi e commossi nel ripescaggio di dettagli e citazioni preziose. Tutti erano accomunati dalla presenza di quella sibillina etichetta, “Capolavoro”, che da un lato mi ha sempre ingolosito, dall’altro mi ha messo sul chi-va-là, visto il carattere generalizzato del plauso. E niente, ho buttato giù un commento di getto, non certo una recensione degna di questo nome, solo per fissare ancora a caldo l’impressione.
La trama è di quelle oltremodo essenziali, non che la cosa sia di per sé un difetto. Segue grosso modo mezzo secolo di vita di William Stoner, figlio di contadini del Missouri spedito in una vicina università a caccia di una laurea in agraria, nella speranza di ottenerne un grosso beneficio in termini di conoscenze sulle più moderne e fruttuose tecniche per la coltivazione. Neanche a dirlo, l’imbelle William scopre una peraltro esangue passione per la letteratura inglese e cambia strada, laureandosi proprio in ambito letterario e poi reinventandosi, nella medesima sede, in un docente universitario dapprima alquanto scarso, e poi sempre più autorevole (ancorché mai troppo apprezzato). Si sposa con una donna che non lo ama, e che imparerà col tempo a contraccambiare, nel più classico dei matrimoni infelici dai quali nasce un altrettanto infelice figlia. Solo l’inflessibilità in ambito lavorativo gli consentirà di risparmiarsi una debacle su tutta la linea, pur costringendolo a esiti rovinosi tanto in termini di carriera che di diversivi sentimentali. A metterla giù così, sinteticamente, quello che emerge è il quadro di un testo piuttosto “rischioso”. C’è oggettivamente poca ciccia, e questo per qualcuno potrebbe rappresentare un problema. Non mi aggrego a quella schiera perché da sempre noia e lentezza non mi spaventano, se l’arte interviene a soccorrere l’opera a compensarne la monotonia, o il pallore. Nel caso di “Stoner” la prosa è effettivamente molto piana e compassata, solo che di compensazioni mi rincresce ammettere di non essere riuscito a trovarne. E’ un libro scritto bene, sarei ingiusto fino ai limiti della disonestà se affermassi il contrario. Però è anche esangue, privo di nerbo, colore e profondità. Il fatto di suonare monocorde mi riesce persino veniale, come difetto, perché posso riconoscervi un preciso intento stilistico che ne dia giustificazione. In questo dimostra anzi una coerenza che a suo modo riesce ammirevole. No, la pecca vera di “Stoner” è di volersi giocare la carta del realismo senza brillare affatto per autenticità. Di tutti i personaggi principali in scena non ce n’è uno che riesca davvero credibile: non il protagonista, bloccato nel cliché (qui, se non altro ante litteram), della figurina che letteralmente si lascia vivere, e arriva a guardarsi dal di fuori mentre i momenti capitali della sua esistenza si palesano. Personalmente, questo è uno di quei luoghi letterari abusati che mi infastidiscono. Di più, nel vissuto di questo William Stoner non c’è traccia di passione o consapevolezza, eccetto che in una relazione extraconiugale ben poco plausibile e in una estemporanea presa di posizione, in ambito accademico, che guarda caso gli costerà molto cara. Ancor peggiori, nel romanzo, appaiono le nemesi del primo attore: la moglie Edith, che non solo manca di polpa psicologica e caratteriale ma viene a tal punto maltrattata dall’autore, che la chiude in un calco di instabilità psichiatrica ed emotiva, da renderla francamente indigesta. Discorso analogo per il collega, e poi diretto superiore, Hollis Lomax, pure costretto a forza nella sua figurina di storpio incattivito e vendicativo da rasentare alla fine il ridicolo. Il meno peggio è allora la figlia Grace, cui pure Williams non ha ritenuto di dover offrire lo spessore che forse sarebbe stato necessario. Tralascio di rimarcare tutta una serie di altre soluzioni inverosimili a livello di trama, dal figlio unico di contadini poveri che si concede il lusso di una (pur poco redditizia) carriera universitaria al fatto che il medesimo professore, poco apprezzato ma comunque autorevole, non esca in sessantacinque anni di vita da un guscio di centocinquanta chilometri mal contati. Il finale se la cava direi con mestiere, anche grazie a una suggestione toccante piazzata al posto giusto, nonostante un velo di maniera. Non riscatta il libro, però.
Insomma, per quanto mi riguarda, lo status di “cult book” e la scintillante nomea di “capolavoro ritrovato” sono francamente fuori luogo, oltreché generosi. Facendo piazza pulita dei facili entusiasmi con cui venne accolto nel suo rilancio, dieci o quindici anni fa, “Stoner” è un romanzo discreto, buono se proprio siete dei patiti della letteratura sfrondata e dall’andamento molto lento, privo di guizzi o grandi sussulti. Sono troppo severo? Magari sì, e ho accentuato i difetti fino a condannare il libro a una sorta di caricatura. Può anche essere, potrei aver agito con una qualche premeditazione, pur non conoscendo affatto John Edward Williams e il resto del suo lavoro. Il mio guaio, con “Stoner”, è che ho avuto la sventura di leggerlo tra due romanzi di Richard Yates, i soli che ancora mi mancavano e nemmeno i suoi migliori, “Una buona scuola” e “Il vento selvaggio che passa”. Beh, non me ne vogliano gli estimatori di questo testo, ma il confronto a caldo è stato a dir poco impietoso. Anche nei suoi lavori “minori”, Yates riusciva davvero a suonare vivo e credibile in maniera impressionante, sapeva scoperchiare baratri nell’animo dei suoi personaggi, riuscendo a includere con efferata maestria nel ritratto anche noi lettori, scaraventandoci addosso quella sorta di umano pietrisco, ferendoci e sconcertandoci per tutta quella verità. Realismo sporco, si diceva. Beh, non è tra le pagine di “Stoner” che riuscirete a trovarlo.
5.8/10