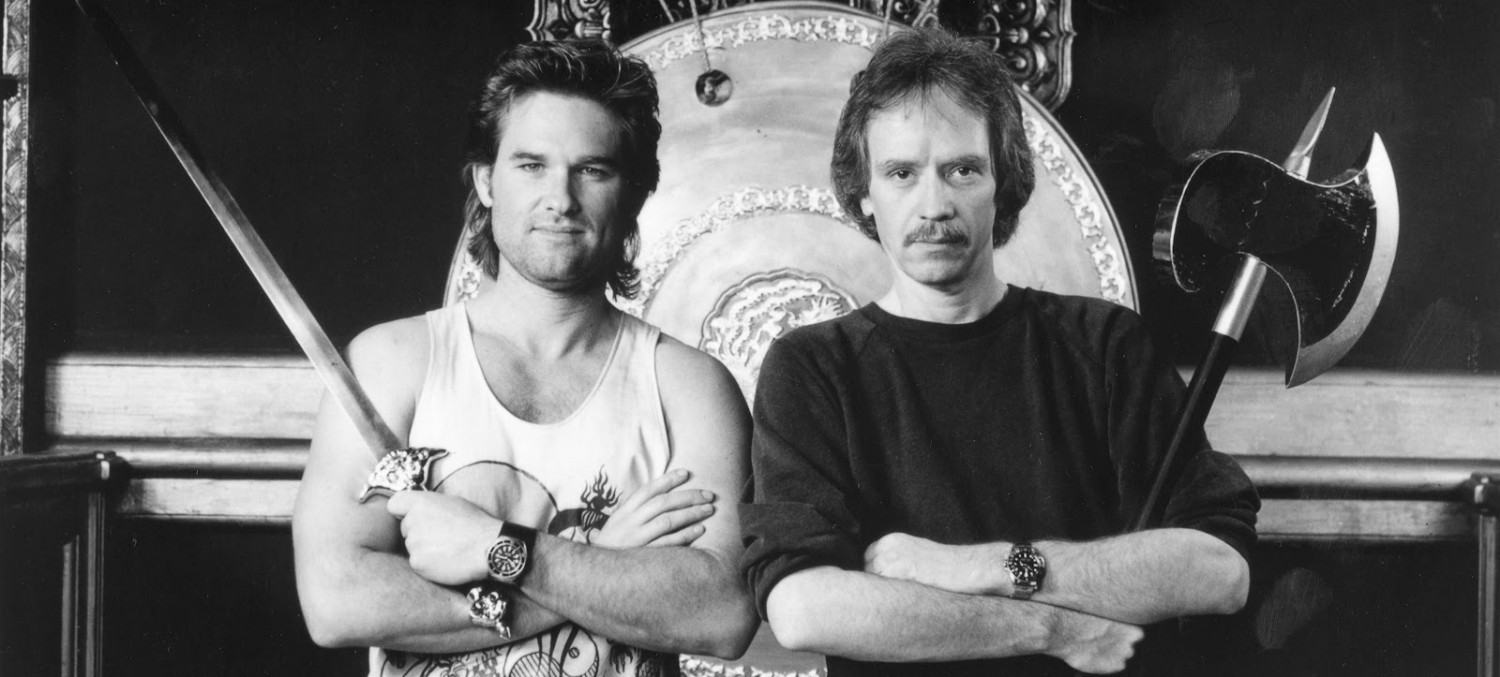Tre contadini che vanno a ballare _Letture
E ora spazio a un titanico capolavoro. Non credo ci siano altre etichette plausibili per l’esordio letterario (ormai trentenne) di Richard Powers, una folgorazione autentica per il sottoscritto. Un libro di quelli ostici sul serio “Three Farmers on Their Way To a Dance”, un pozzo di rimandi, una vertigine di incroci tra fiction e nonfiction da stordimento. Ma anche un’esperienza totalizzante e gratificante, se si è dotati di una pazienza di molto superiore alla media e, perché no, di un amore smodato per la storia. “Storia”, sia ben chiaro, da intendersi anche con la esse minuscola: la genealogia, quel patrimonio di avventure sepolte che potrebbe diventare il romanzo speciale di ognuno di noi, se solo trovassimo il coraggio di scavare (con mio fratello, ad esempio, siamo risaliti per la mia famiglia al 1440, a un altro cognome – Chapiron – e ascendenze subito al di là delle Alpi). L’opera di Powers ha avuto vita facile con me anche per una ragione così banale, ma è indubbio che sia stata la sua complessità di artificio intellettuale prima che narrativo a stimolarmi, a rappresentare una sfida che mai avrei rinunciato a condurre in porto. Nel mio caso la ricompensa è stata notevole: la scoperta dell’arte di quello che nel libro appare come un idolo sullo sfondo, quell’August Sander autore dell’immagine servita da pretesto per questa epica pirotecnia narrativa e concettuale. Un pioniere della fotografia o comunque uno dei primi veri artisti in quel campo. A Parigi, qualche mese fa, ho trovato e acquistato un’opera monografica a lui dedicata e ribadisco che una bella fetta del fascino di “Three Farmers on Their Way To a Dance” è merito suo. Suo e dei suoi improvvisati modelli di strada, si intende.
Tre giovani contadini del Westerwald, in cammino nel tardo pomeriggio primaverile verso un ballo di paese, si imbattono in un distinto gentiluomo in bicicletta. Affascinato dai loro volti interessanti e nel contempo caratteristici, questi si offre di ritrarli nell’abito buono della festa con la sua macchina fotografica, in cambio di una cifra simbolica. E’ il primo maggio 1914 e neanche tre mesi dopo la guerra irromperà sconvolgendo la loro tranquilla quotidianità e segnando nel profondo il loro destino. Alcuni decenni più tardi l’istantanea, scattata in quell’occasione da un tutt’altro che sconosciuto maestro dell’obbiettivo ai tre fratellastri mezzi tedeschi e mezzi olandesi, Hubert, Peter e Adolphe Kinder, incontrerà lo sguardo di un osservatore speciale ed evidentemente predestinato nella città dell’automobile per eccellenza, Detroit, rendendo in fondo necessaria l’indagine che ne riveli gli emblematici retroscena alla vigilia della Grande Guerra. E, più o meno in contemporanea con questa folgorazione, una seconda stupefacente epifania vedrà in quella stessa immagine una cruciale svolta in termini di consapevolezza, quando si manifesterà come rivelazione finale agli occhi dello stralunato redattore di una rivista di micro-tecnologia, Peter Mays, a caccia della verità sulle proprie ascendenze europee.
Tre storie scorrono apparentemente indipendenti nel tempo e nello spazio, ma sono destinate a convergere. La prima è il racconto di un’ossessione, in prima persona, con la voce di un narratore che nulla vieta di identificare nello stesso autore Richard Powers, rimasto segnato dall’incontro del tutto casuale con questo eccezionale documento d’inizio novecento. “Chi l’ha scattata? In quali circostanze? Che cosa significa?”, si domanda l’io narrante sul ciglio di un baratro di affannose e, per lunghi tratti, infruttuose ricerche. La seconda linea è quella che romanza con disinvolta licenza, ma anche con indubbia verosimiglianza, i vissuti dei tre soggetti di quella stesso scatto. La terza ha invece un più canonico sviluppo romanzesco, in una forma brillante e spudoratamente anni ’80, ed è anch’esso il resoconto di una tortuosa ricognizione nel passato e di un non meno lacerante turbamento. A premiare con la vertigine del senso e a entusiasmare il lettore che si sia dimostrato paziente quanto basta, nonché opportunamente bendisposto nei confronti degli arditi paradossi logici, penserà nelle battute conclusive l’incontro di queste tre direttrici solo in linea teorica divergenti: con le vorticose evoluzioni contaminanti tra fabula e intreccio e la scoperta che un ramo non è altro che la diramazione fantastica dell’altro, la sua genesi beffarda, il frutto dell’immaginazione salvifica di un personaggio a sua volta immaginato.
Gli spunti di riflessione degni di nota sono innumerevoli, nei primi due filoni soprattutto. L’insistenza con cui il narratore individua nessi sorprendenti tra Henry Ford, Sarah Bernhardt e il fotografo August Sander, autore dell’istantanea eletta a fulcro dell’intero testo – qui elevati al rango di figure archetipe chiave della svolta del secolo, in concomitanza con gli sconvolgimenti del primo grande conflitto mondiale – apre la narrazione a un profluvio di considerazioni di natura storica, filosofica, sociologica e antropologica su alcune delle più determinanti rivoluzioni culturali nella storia dell’umanità. Inevitabile lasciarsi travolgere e perdersi in questa ricchezza di valutazioni invariabilmente pregnanti e spesso sorprendenti, ma senza mai prestare il fianco alle un po’ logore lusinghe di un fatalismo di comodo, come spesso capita nei romanzi d’impronta storica sempre a caccia di sensazionali colpi di teatro. In “Tre contadini che vanno a ballare” tutto questo non accade. Il testo è sì in odore di bulimia informativa, di sovraccarico e confusione senza confini, ma la grandiosa regia di Powers sa rivelarsi all’altezza della propria smisurata ambizione, scongiurando con originale eleganza ogni deriva fine a se stessa e soprattutto avendo cura di non perdere mai di vista la nobile missione di una tesi divulgativa che è anche pirotecnica invenzione letteraria di pura finzione.
A cavallo tra fiction e non-fiction, indagine documentaristica e dedalo postmoderno, è aperta la strada a un ragionamento mai banale sull’idea stessa di opera d’arte, sulla sua riproducibilità in serie, sul ruolo e lo sguardo del creatore e la dignità di chi è chiamato a raccogliere la sua urgenza nel presente come nel futuro. Un romanzo infarcito di iperboli, digressioni nozionistiche e considerazioni alte, a suo modo titanico per la mole delle pretese dettate al suo fruitore e per i cortocircuiti interpretativi cui di continuo sottopone quest’ultimo. Un’architettura narrativa monumentale, convulsa, affascinante, che non mancherà di ripagare chi si faccia carico di uno sforzo intellettuale non indifferente, come in Pynchon e a tratti meglio che in Pynchon, in virtù della sua concretezza mirabile. E’ anche il lavoro “struggente del formidabile genio” Richard Powers qui alla sua opera prima, un programmatore innamorato della storia, capace in seguito di confermare in pieno la straordinaria prova di talento di questo magistrale esordio. Un romanzo difficile, insomma, non certo di quelli d’evasione che si lasciano divorare in tre giorni. Che può però trovare uno sbalorditivo completamento nella visione delle meravigliose testimonianze lasciateci da Sander.
Consiglio di dedicarcisi a lettura ultimata, come sorta di premio per la vostra piccola impresa di lettori volitivi. Basta digitare “August Sander” su google immagini e dare un invio. Difficilmente, se avete apprezzato “Tre contadini che vanno a ballare”, resterete delusi dallo sterminato potenziale di storie non raccontate, racchiuse negli sguardi lontani di questi silenziosi protagonisti del secolo scorso.
9.4/10