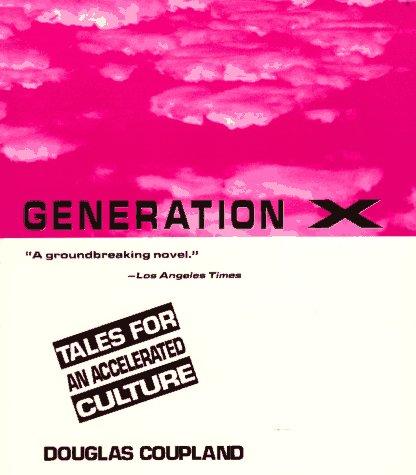Fidanzata in coma _Letture
Qualche anno fa ho preso una sbandata per Douglas Coupland, forse l’autore del quale ho scritto maggiormente qui dentro. Un’infatuazione ragionevole, considerando che i primi suoi romanzi che ho letto sono “Generazione X” e “Microservi”, i migliori (e per distacco) di un catalogo già piuttosto ricco. Dopo un’infilata di mezze boiate ho recuperato questo “Girlfriend In A Coma”, uno dei due testi a suo nome pubblicati in Italia da Feltrinelli, relativi a una fase ancora piuttosto remota nel tempo (1998) e quindi con buone speranze. Pareva uscirne una delle sue opere più desolanti e meno autoreferenziali, grazie al cielo, una sorta di fuori onda più che disincantato dell’era Reagan e dell’era Clinton, non fosse che il canadese ha poi deciso di riservare una doppia sterzata narrativa – prima di taglio macabro, poi all’insegna di un miserabile buonismo – che sul lettore smaliziato ha l’effetto di un Ko. Magari sono io a recitare la parte del duro, come ogni innamorato scottato un passo alla volta dalla delusione. Forse ci si può accontentare del titolo rubato alla canzone degli Smiths, o delle plausibili ricadute cinematografiche del libro forse più cinematografico del Nostro (in un certo senso ero stato buon profeta nella recensione, anche se la serie Tv della NBC con Christina Ricci è stata cancellata poco dopo l’annuncio) però, non so, ho l’impressione che il buon Douglas, oggi drammaticamente a corto di idee, qui abbia voluto esagerare e abbia di fatto “sputtanato” una delle sue cose più pregevoli. Il mio amore per lui, ad ogni buon conto, si è da tempo raffreddato.
Vancouver, Dicembre 1979. In un tranquillo sobborgo abitato da un “ceto medio, che più medio non si può”, sei ragazzi prossimi al diploma trascorrono le loro giornate all’insegna della spensieratezza, tra gite sulla neve e allegre serate alcoliche. Hanno da poco perso un compagno cui erano tutti legati, Jarod, stroncato dalla leucemia, ma cercano di non scoraggiarsi facendo affidamento gli uni sulla compagnia degli altri. Sarebbero solo buoni amici ma di fatto costituiscono tre potenziali coppie d’acciaio: lo scavezzacollo Hamilton e la svampita Pam, legittime aspirazioni da modella e relative ossessioni alimentari; i cervelloni Linus e Wendy, due con la testa il più delle volte tra le nuvole e voti ampiamente sopra la media; e poi Richard e Karen, quelli più “normali” della cricca, verrebbe da dire, quelli tra cui l’amore vero sembra sul punto di sbocciare. E sotto una trapunta di stelle, su una cresta innevata, una sera la magia si compie davvero. E’ la prima volta per entrambi, sembra l’inizio di una bella storia sentimentale tra adolescenti, ma qualcosa non va. Lei è strana, confessa di sentirsi minacciata da qualcosa di oscuro, lamenta una certa inquietudine per alcune fosche visioni che ha avuto e affida molti dei suoi timori sul futuro a una lettera che consegna al ragazzo, pregandolo di aprirla solo nell’eventualità che qualcosa di brutto le capiti. Il ché accade puntualmente forse neanche un paio di ore dopo. La giovane prende un valium, lo accompagna con un paio di drink annacquati e poi crolla a terra, abbattuta come da un fulmine a ciel sereno. Non si risveglierà che diciassette anni dopo, deperita nel fisico ma con lo stesso brio di un tempo, solo per scoprire di aver avuto una figlia, Megan, cresciuta poi in sinergia forzata da sua madre Lois e dal fidanzato dei giorni felici.
E’ proprio Richard a diventare così, prestissimo, il protagonista della vicenda, il punto di osservazione privilegiata tramite cui seguire con i sei ex sodali l’appassire di un legame che non si spezzerà mai del tutto, e che troverà anzi nuova benzina dall’insperato risveglio della bella addormentata. Attraverso la soggettiva del giovane ci è offerto un manuale di disincanto in perfetto Coupland-style, amareggiato magari ma mai cinico. E si attraversano tutti d’un fiato gli anni ’80, le cui contraddizioni e falsi miti rappresentano una pietra tombale inequivocabile per i sogni ancora innocenti dei due decenni precedenti. Si entra nei novanta della “Generazione X” – sempre lei! – e le miserie di un’età adulta ormai priva di vere bussole sono apparecchiate con la consueta disinvoltura, anche grazie a un campionario simbolico che per chi abbia letto altro dell’autore non potrà che suonare risaputo, almeno in parte. Certo c’è meno ironia del solito, non si ride che a denti stretti, la rassegna di simpatiche bizzarrie è ridotta all’osso mentre l’ormai trita autoreferenzialità del romanziere canadese resta espediente non pervenuto, grazie al cielo. Il diventare adulti, in Coupland, non è mai stato tanto desolante. Chi aveva un bel cervello lo ha impiegato male. Chi ha sfondato nella moda ne è poi uscito con le ossa rotte. Chi ha ceduto alla droga è condannato a un presente di dipendenze e sostanziale solitudine. E poi c’è Richard, che continua a essere quello “normale” del lotto, anche se la paternità da minorenne non la si può archiviare tra gli eventi ordinari, e le difficoltà della salita vanno a crescere esponenzialmente con la pendenza: l’alcolismo diventa lo sbocco inevitabile per chi non aveva gli strumenti adatti a sobbarcarsi tutto il peso del mondo, e si offre anche nel contempo come il più comodo dei luoghi comuni letterari, giustificando non senza opportunismo la quotidianità sbandata dell’acerba Megan.
Quando l’adolescenza finisce, i sei compagni un tempo inseparabili si trovano allora, spesso e volentieri, separati per forza. Dell’amica in coma finiscono per dimenticarsi tutti, tranne il padre di sua figlia, e tutti si ritrovano a vivere nella certezza che la vita “possa acquisire magicamente significato da un attimo all’altro”, credendoci però sempre meno ogni giorno che passa. Invecchiano senza diventare saggi. Si sentono persi, incarogniti, “assestati con calma in un autunno della vita prematuro” in cui il divertirsi occasionale e poco consapevole non è altro che un velo a occultare l’isteria sottostante. Come nelle tremende premonizioni ricevute in gioventù, Karen si trova circondata da una congrega di “anime impantanate” che non hanno saputo far fruttare le proprie ambizioni, che hanno dimenticato la forza propulsiva dei sogni e si sono trasformati in quel che sono “per pura inerzia”. Ma arrivati a questo punto siamo solo a metà dell’opera. Accade il miracolo, è vero; ma anziché sedersi su allori strappalacrime, Douglas regala una bella sterzata, alquanto imprevista: oscura il cielo di bei nuvoloni neri, alza la posta dell’inquietudine con nuove sinistre evocazioni e, per non farsi mancare proprio nulla, si concede una notevole sbertucciata alla tv del dolore e all’ipocrisia del circo mediatico. Quindi spalanca le porte dell’apocalisse, con una perfidia grottesca degna di un Christopher Moore – le pagine dedicate all’ecatombe collettiva sono le migliori del libro, checché se ne dica, e con la loro amabile galleria di “squaglioni” umani superano il tanto celebrato “Un Lavoro Sporco” – e segna di fatto l’avvio di un’opera del tutto diversa, cupa, conturbante e disperata, ma abbastanza avvincente. Peccato che il gioco non duri a lungo, e il canadese inquini le ultime ottanta pagine con un buonismo da “seconda opportunità” che manda in vacca il tesoretto di tensione sapientemente raggranellato e che non potrebbe essere più fuori luogo di così. Il romanzo forse più denso e irregolare del suo catalogo, quello che meglio si presterebbe per una (o più di una, vista la varietà di spunti) riduzione cinematografica, va allora in archivio all’insegna di una speranza incondizionata nelle nuove generazioni (ipsilon o zeta, se i conti sono giusti) e di una sorta di “Stay hungry, stay foolish” ante litteram che puzza di (mezza) delusione.
Peccato, resto convinto che Coupland sia uno scrittore valido proprio per come sa gestire le emozioni, sentimentale senza sentimentalismi. Nel caso di “Fidanzata in Coma” ha finito per essere troppo didascalico proponendo a forza una morale (e un fantasma risibile) di cui non si avvertiva il bisogno, così un po’ di perplessità è da mettere in conto.
6.4/10