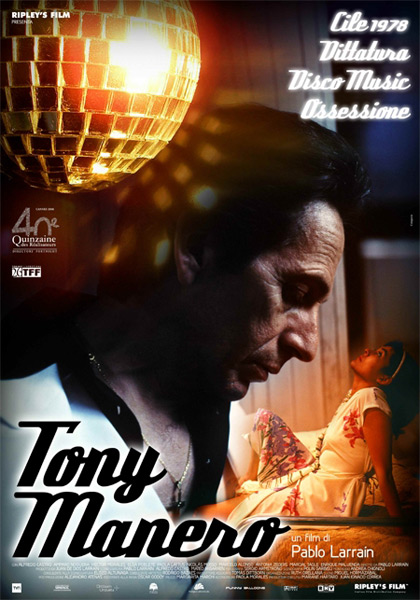Days Come and Go
In una delle scorribande serali con il mio amico Steno li incontrai. Era il primo anno di università, un secolo fa praticamente, e quelle erano benedette fughe dall’ovvio. Steno aveva una vecchissima cinquecento ed un lettore di cassette. Aveva anche delle cassettine fatte da lui, copertina compresa, copiate da qualche disco strano dei più strani tra i suoi amici. Una sera infilò questa bella cassetta nel lettore e filammo via, nella notte, tra corso Casale e zona Vanchiglia. Su un lato c’erano gli Asian Dub Foundation, roba che puntualmente mi faceva ascoltare e che cominciavo ad avere a noia. Sull’altro lato però c’era roba mai sentita, canzoni pop tranquille e con una fracca di parole dentro, con qualche ingenuo passaggio di elettronica povera. Il disco si chiamava ‘Tigermilk’, ‘The State I Am In’ mi piacque all’istante. Chiesi chi erano, solita scontata battuta sul cartone animato e poi via, pensieri già a qualcosa di nuovo. Qualche sera dopo eravamo nella casa in Crocetta di un paio di suoi amici, gente ricca sfondata ed annoiata, borghesi della peggior specie. Sfogliavo distrattamente una rivista di musica con la speranza che ci levassimo presto da quella solfa quando Steno mi interruppe mostrandomi la recensione di un disco nuovo, con una bella copertina verde. Erano loro, quelli della cassetta. Il giorno dopo comprai quello stesso disco, che mi piacque ma non quanto quello assaporato sui viali del lungopo sulla cinquecento. Decisi di ritrovarlo e così mi procurai in brevissimo tempo tutto il resto: il mini con la copertina gialla, quello con la copertina viola e quello con la copertina bianca, il disco con la copertina rossa e finalmente quello con la copertina grigia (o azzurra, mai capito). Erano quelli i giorni in cui mi innamorai di Belle & Sebastian e proclamai ufficialmente aperta la caccia ai migliori emuli di quel gruppo: qualunque cosa suonasse molto simile a quella band non poteva che piacermi ma…esisteva qualcosa di veramente simile? Col tempo provai di tutto (perfino roba tipo ‘It’s Jo and Danny’), spesso uscendone deluso, altre volte con qualche nome prezioso in più in agenda. Leggendo in un articolo di Bordone sul Mucchio l’ennesimo accostamento con l’indiepop da cameretta di Murdoch e Jackson, comprai i primi dischi di altre due band scozzesi tutto sommato personalissime che mi sono comunque rimaste nel cuore: in una cantava una Campbell che non era Isobel, nell’altra un tizio di nome Gordon spacciato non a torto come il nuovo Morrissey. Di musica perfettamente accostabile a quella dei Belle & Sebastian, però, nessuna traccia. Mai trovata una band equivalente, e infatti questa ricerca inutile è un gioco che non mi interessa più. Se mi ci dedicassi ancora, sarei forse stupito nel rilevare che anche il gruppo che ancora pubblica dischi con quella ragione sociale è solo una pallidissima copia della band formidabile di quei primi album. Se mi ci dedicassi ancora potrei entusiasmarmi per qualche minuto, lasciando scorrere i primi brani di questo esordio degli svedesi Mockingbird, Wish Me Luck. L’entusiasmo si spegnerebbe dopo qualche frangente e non reggerebbe di certo un numero consistente di altri ascolti. C’è l’imitazione, appunto, mentre il talento (che si scorge a tratti, bisogna dirlo) è ancora abbastanza acerbo. Nel complesso il disco è carino, sincero, ben suonato. Ma non sorprende davvero, non può farlo. Resta l’ennesima testimonianza di come i giovani musicisti svedesi ci sappiano fare (per la cronaca questo batte il nuovo di Pelle Carlberg sullo stesso terreno, anche se esce sconfitto in quanto ad ironia dal tenerissimo "Pelle & Sebastian" scandinavo). Viene da dire che la stoffa c’è e che i ragazzi sapranno come crescere e migliorarsi. E’ anche vero, però, che se ci hanno messo cinque anni per registrare le loro prime nove canzoni potremmo dover aspettare moltissimo tempo per raccogliere i frutti di questa semina.