Cold Spring Harbor _Letture
Riecco Yates. L’avevo lasciato nel baratro di amarezza e follia di John Wilder in ‘Disturbo della quiete pubblica’ e lo ritrovo nei sogni infranti della desolata provincia americana di ‘Cold Spring Harbor’, suo ultimo lavoro. Avevo dubitato che quel libro, da me definito all’epoca “eccezionale” senza esitazioni, fosse davvero la sua opera peggiore, come in tanti sostengono: beh, dopo aver aggiunto una spunta all’elenco dei suoi romanzi, posso affermare se non altro che questo secondo titolo è, possibilmente, addirittura “un po’ più eccezionale” di quello. E’ scritto con una fermezza raggelante, con onestà, è una fetta di vita vera. Non soltanto perché si tratta dell’opera più autobiografica dello scrittore di Yonkers, ma proprio perché i personaggi in scena sono terribilmente autentici come i loro drammi senza clamore, come il silenzio delle loro passioni e della loro frustrazione. E’ impressionante Richard Yates, erano anni che non mi imbattevo in un romanziere capace di farmi divorare un libro in due giorni. Di sicuro questo non capitava in casi in cui la materia narrata avesse una connotazione tanto realistica e deprimente, visto che in genere è la fuga dalla realtà a porsi come proposta allettante, non il contrario. Secondo cinque stelle Anobii su due, quindi, per l’autore di ‘Revolutionary Road’. Media impeccabile che immagino sarà confermata anche dopo la lettura del suo romanzo più noto, trovato qualche settimana fa intonso in un mercatino dell’usato ad un euro e cinquanta, edizione Garzanti del ’66 ancora con il primo titolo italiano, ‘I non conformisti’. Finisco i racconti di Carver, leggo un po’ di Buzzati e poi via, mi ci dedico.
A Cold Spring Harbor, cittadina residenziale di Long Island e rispettabile buco nel bel mezzo del nulla, il matrimonio di Evan e Rachel segna l’ incrociarsi dei destini di due famiglie. Da una parte gli Shepard: uno sposo privo di grandi passioni e che nemmeno un precedente matrimonio (con paternità) aveva saputo far maturare, suo padre Charles, militare andato in pensione prima del tempo per accudire la moglie, e proprio quest’ultima, Grace, sprofondata da anni in un baratro di alcolismo, depressione e disagio mentale. Dall’altra i Drake: il padre Curtis, in perenne latitanza, la madre Gloria, egocentrica querula, squilibrata e con troppi vizi in curriculum (fumo, superalcolici, nomadismo compulsivo), il figlio Phil, da tutti trattato alla stregua di un bambino ma desideroso di emanciparsi il prima possibile, ed appunto la novella sposa, una ragazza assennata quanto conformista e succube dell’ingombrante genitrice.
Il settimo ed ultimo romanzo di Richard Yates è poco più che uno spaccato. L’azione è ridotta all’essenziale, non succede nulla di particolarmente eclatante ed anche la chiusura lascia inalterate le vicende dei protagonisti. Messo in questi termini potrebbe sembrare un semplice ritratto corale privo di particolare interesse, ma la realtà è che si tratta dell’ennesimo capolavoro di un autore ancora incredibilmente poco conosciuto, almeno dalle nostre parti. Poca azione, si diceva: non certo un problema per uno scrittore realmente straordinario nel rendere le psicologie ed i legami interpersonali – con il loro carico di silenzi, di ellissi, con tutti i relativi impliciti rapporti di forza, con il peso delle convenzioni consolidate – più che la pirotecnia di una fabula forzatamente avvincente. A Yates interessavano gli esseri umani al netto degli artifici letterari, la famiglia come teatro di piccole quotidiane miserie, ed in tal senso ha ragione chi ha parlato di ‘Cold Spring Harbor’ come di una polveriera di sentimenti inesplosi. A dominare la lettura e renderla un’esperienza così impetuosa è la tensione invisibile ma latente di cui le oltre duecento pagine sono impregnate.
Lo sguardo di Yates è rivolto come una macchina da presa del nostro Neorealismo ad una ristretta galleria di anime periferiche, condannate per loro natura ad una desolante e quasi commovente immobilità. Tutti i personaggi (tranne forse Mary, la prima moglie di Evan) soffrono senza clamore come avvelenati poco alla volta dalla consapevolezza di una frattura non più recuperabile dentro di loro, lo scarto fra ciò che avrebbero voluto (e ancora vorrebbero) essere e ciò che sono in realtà. Con la precisione di un entomologo l’autore di ‘Revolutionary Road’ si sofferma sull’insulsa normalità dei Drake e degli Shepard ma anche delle figurine secondarie, sulla dipendenza irriducibile dalle proprie e dalle altrui debolezze, sul bagaglio di aspirazioni e buoni propositi puntualmente disattesi e destinati a languire in una secca di rancore strisciante e sostanziale impotenza.
Yates non è spietato come molti hanno detto. E’ un umanista che non silenzia la disperazione. Fa recitare a turno i suoi attori ma si tiene sempre a debita distanza dal loro dramma, aiutando il lettore a scongiurare il fardello di una completa immedesimazione. Con pochi tratti brucianti ed essenziali riesce a caratterizzare in maniera miracolosa l’intima sostanza dei diversi personaggi, ed il realismo e l’onestà della sua narrativa si confermano ancora una volta limpidissimi, mirabili, non comuni. E’ questo minuzioso lavoro multiprospettico, con la sua verità non adulterata, a lasciare realmente ammirati. Il modo in cui va svelare il retropalco di ansie, egoismi spiccioli ed insoddisfazione che fa da contraltare al perbenismo apparente e radioso delle comuni famiglie della classe media. E non importa che si parli degli anni ’30 e ’40. La sua impietosa indagine su una crisi generalizzata non potrebbe essere più attuale.
‘Cold Spring Harbor’ racconta la fine delle illusioni giovanili, l’incomunicabilità, il senso di vergogna e solitudine, la voglia frustrata di ascesa sociale e riscatto, con lo sfavillio del Sogno Americano ridotto mai come ora ad un miraggio beffardo, un fondale di cartone schiacciato dall’onda lunga della Grande Depressione ed ancora terribilmente lontano dai luminosi anni ’60. Il pessimismo di fondo è asciutto, mai gratuito, privo di aneliti moralistici e senza la minima scoria di cinismo. Yates non era uno scrittore sadico, tutt’altro. Sentiva il bisogno di mettere in scena e raccontare un po’ della propria infelicità, ed è forse per questo che il suo ultimo romanzo va letto in prospettiva come quello in assoluto più autobiografico. Nei panni di Phil, goffo ma vitale, non vi è altri che il Richard ragazzo: acerbo, insicuro senza una figura paterna, funestato da una madre straordinaria solo nel dispensare sensi di colpa, ma in fondo ancora in grado di scegliere con la propria testa e di smarcarsi almeno fisicamente dai demoni soffocanti di un mondo sciatto e privo di colore.
Accanto a lui, una rassegna di personaggi emblematici ed indimenticabili. La terrificante Gloria Drake in primis, fantasma della madre Dookie ed icona quasi sublime del patetico e del melodrammatico, maestra del sopra le righe in perenne affanno nella sua rincorsa impossibile ad una rispettabilità idealizzata fino alla nausea. La “donna che muore d’amore” per il consuocero Charles, uomo decoroso, paziente e armato di tanto buonsenso, ma con troppi fantasmi ingombranti nel passato e nel presente, e con più di una responsabilità nello sfacelo psichico di sua moglie Grace. Il figlio Evan incarna invece tracce del ribellismo della (imminente) gioventù bruciata ma in maniera mediocre, inconcludente, senza alcuna profondità romantica o tragica che sia, e come gli altri non riesce a suscitare simpatie nel suo veleggiare privo di rotta, né antipatie per l’adulterio o il disprezzo riservati all’impalpabile Rachel.
L’Alcool e la guerra sono presenze sottili ma costanti, quasi coprotagonisti. Il primo è la linfa che accompagna e scandisce le giornate vuote di tutte le miserabili pallide esistenze della cittadina di provincia. Bevono le due madri, una per evadere più agevolmente la realtà, l’altra per farsi coraggio e rendersi ancora più insopportabile nel suo profluvio di parole fuori luogo. Bevono gli Shepard, per dimenticare le gabbie in cui il loro arbitrio li ha reclusi. Beve Curtis Drake, che nemmeno si degna di accompagnare al treno dell’addio il figlio più giovane, e beve anche quest’ultimo – solo birra però – nelle prove generali di una vita adulta. La guerra non è da meno come pensiero ritornante. Lasciapassare per una vita finalmente diversa, patente di rispettabilità sociale o pozza dei propri più accesi rimpianti, è una realtà con la quale tutti i personaggi maschili si trovano in qualche modo a doversi misurare.
E poi c’è il finale, a suo modo memorabile. Volutamente irrisolto, lascia in sospeso ogni possibile sentenza, affidando alla vena del lettore il piacere di ritrovarvi una condanna amara e senza appelli oppure un barlume di speranza quasi fuori tempo massimo. L’eccezionalità di Yates risiede anche in questa magistrale ed umanissima ambiguità che pochi come lui hanno saputo dispensare con tanta sfacciata disinvoltura.

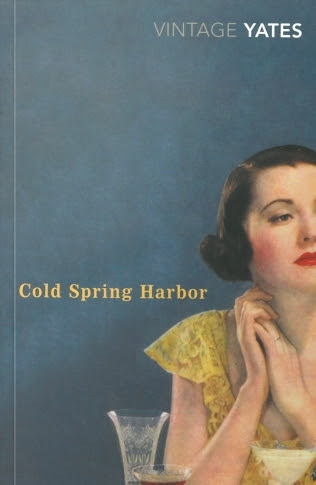

keepmehere
novembre 19, 2012 at 2:58 pm (11 anni ago)quando ero alle medie mi fecero leggere un racconto di Buzzati (sai no quelle robe da antologia per avvicinare i ragazzini alla lettura). Si intitolava IL COLOMBRE e me ne innamorai pazzamente. Ne sono passati di anni e di libri e di racconti, ma quello rimane ancora il mio preferito.
Lo so che l’argomento non era propriamente questo, ma volevo dirtelo, boh