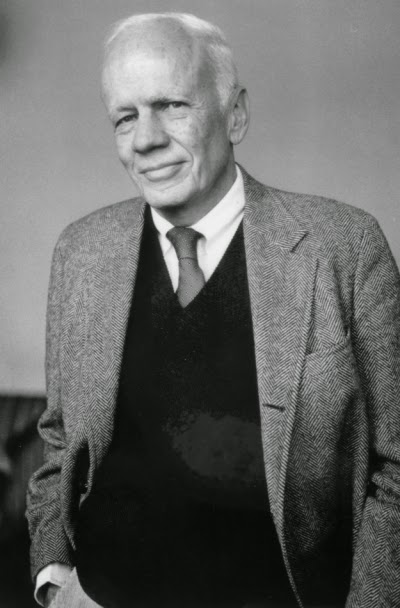I only wanted to be sixteen… and free

L’altra notte non riuscivo a prendere sonno. Come talvolta capita tra un volteggio e l’altro nel letto, del tutto incapace di imporre la sordina al cervello nelle sue divagazioni retrospettive e fuori orario, mi sono ritrovato non so come a pensare al 1995. Annata di dischi a loro modo memorabili, di svolte importanti mie come del rock alternativo. Forse mi ha spaventato la consapevolezza che il 1995 era venti anni fa, anche se a me sembra ancora l’altro ieri, o forse è stato l’aver visualizzato il nome del desaparecido Richey Edwards provando a immaginare il più comodo degli anniversari in tema. Lasciando quel misterioso primo febbraio e riportandomi sull’attualità del mese in corso, per provare a celebrare una ricorrenza con ancora un minimo di puntualità, mi è tornato in mente un morto certificato e non solo apparente, forse dimenticato oggi ma per il sottoscritto ancora sufficientemente “caldo”: Shannon Hoon, il frontman dei Blind Melon, scomparso il ventuno di quel mese e di quell’anno per un’overdose di non ricordo quale droga, capirai che originalità. Perché tirare fuori dal dimenticatoio una figura volente o nolente di seconda fascia, per giunta fastidiosamente prevedibile nella sua parabola di rockstar bella, maledetta e con il finale già scritto? Beh, forse perché per me questo scavezzacollo col microfono non è stato proprio uno tra i tanti. E poi perché non riesco a togliermi dalla testa, anche oggi che le sue canzoni non le ascolto praticamente da secoli, che il suo potenziale fosse davvero fuori dal comune, almeno per quei tempi, che con un’altra testa e un’altra disciplina questo ragazzo avrebbe anche potuto diventare un piccolo eroe generazionale.
Invece se ne andò da pirla durante un tour della sua band, a New Orleans, nel momento forse migliore della carriera, con la beffa di quel mese scarso di ritardo per l’iscrizione all’esclusivo club delle celebrità del rock schiattate a ventisette anni (Hendrix, Morrison, la Joplin, Brian Jones, Cobain ed il succitato Edwards, pur con il suo bel punto interrogativo) . Una popolarità già più che discreta, almeno dalle sue parti, un opportunismo evolutivo prezioso – prendere le distanze dal carrozzone grunge ormai agonizzante e reinventarsi apostolo di un’indie-rock ante-litteram, con il bonus di un pedigree roots non artefatto e ancora tutto da spendere – e a casa, non fosse abbastanza, una figlia appena nata dalla quale tornare ad amplificatori spenti. Nico Blue, la bambina, rimase invece orfana, ed è difficile immaginare che si sia mai sentita in qualche modo compensata di quella perdita dal fatto di aver prestato senza volerlo il proprio nome di battesimo al terzo album della band paterna, una raccolta di outtakes e demo in realtà, uscita postuma alcuni mesi dopo il decesso del genitore.
I Blind Melon erano spuntati dal sottobosco alt-rock quasi per caso, imbarcati da mano generosa, giusto per le lunghe chiome e le camicie a quadri di flanella, su uno dei vagoni di coda del rapido di Seattle, loro che erano tutti immigrati a Los Angeles, chi dal Mississippi, chi dalla Pennsylvania, chi – come il frontman – dall’Indiana. L’avvio si era rivelato stentato, con un EP pronto a essere pubblicato e poi inspiegabilmente abortito, ma le cose iniziarono a girare bene proprio grazie a Hoon e a una sua vecchia conoscenza dai tempi della natia Lafayette: Axl Rose, leader di quei Guns’n’Roses che all’epoca se la spassavano sulla cresta dell’onda con il loro hard-rock milionario, invitò il più giovane collega a prestare la propria voce per i cori di cinque brani nei due capitoli del fortunato “Use Your Illusion”, le celeberrime “Don’t Cry” e “November Rain” incluse. Fu un ottimo viatico pubblicitario per il gruppo, chiamato a quel punto ad accompagnare non solo le superstar californiane ma anche, nel tour di “Badmotorfinger”, una delle compagini di punta della scena grunge, i Soundgarden. Il doppio endorsement avrebbe dato presto i suoi frutti, garantendo al quintetto un contratto con la Capitol e i servigi di un produttore giovane ma già acclamato come Rick Parashar, che con Chris Cornell aveva lavorato registrando l’unico album intestato ai Temple Of The Dog, giusto due anni prima di fare il botto con “Ten” dei Pearl Jam.
Inevitabile a quel punto (e con quei riferimenti) l’apparentamento alla scena di Seattle, forzato quanto si vuole ma equivalente a una benedizione divina per quei promettenti esordienti di provincia. Il disco eponimo che ne scaturì rientrava nel genere in maniera alquanto relativa, presentando sonorità meno ulcerate e una propensione melodica molto più marcata, con concessioni a una psichedelia West Coast tardi sixties e a certe bizzarre tentazioni funk del tutto estranee al dna dei vari Mudhoney, Nirvana o Alice In Chains. Per quanto i testi di Hoon insistessero spesso sul tema della perdizione e del disagio, tanto in voga in quella fase, la musica dei Blind Melon appariva ben più spensierata e frizzante di tante altre uscite del periodo: due chitarre veloci, speziate e molto ben amalgamate, una sezione ritmica ruspante ma non cafona, registrazioni in presa diretta con scarsissimo make-up in post produzione e poi il cantato acidulo e incisivo di Shannon, spesso amplificato prospetticamente dai suoi stessi cori, a rappresentare quasi uno strumento in più nella dotazione del gruppo. Per qualche mese le vendite stentarono, ma il lancio in heavy rotation su MTV della clip di “No Rain” con la sua (fastidiosissima) bambina-ape segnò la svolta. Magari lo ricordate anche voi, nella primavera del ’93 quel video fece furore e spalancò al quintetto le porte del successo, troppo presto – evidentemente – per quel ragazzo fragile che pure riusciva a fare meraviglie con quella voce così genuina.
Io che avevo appena quattordici anni abboccai con fervore appassionato, rapito dall’appeal luminoso di questa combriccola di (apparenti) neo-hippy e dalla loro evidente armonia, la stessa che nei credits traspariva in quella illuminante dicitura, “All songs written by Blind Melon as One”, quasi si trattasse di R.E.M. più giovani. E mi andò bene, tutto sommato, meglio che con altre realtà analoghe che all’epoca, a parte l’immancabile singolo di grido, smerciavano fuffa in quantità. Sotto la crosta croccante, “Blind Melon” era invece anche ciccia, una sporca dozzina di buonissime canzoni, a basso coefficiente di originalità ma sanguigne il giusto e interpretate da un manipolo di giovani con le giuste motivazioni e la necessaria sincerità. In fin dei conti si trattava di una specie di concept sui lati oscuri e dolorosi dell’adolescenza, reso vibrante dall’onestà della prospettiva intimista, come un romanzo di formazione in forma di diario calcato dalla penna sensibile di Hoon. Detto dello smaccato populismo di “No Rain”, per paradosso (forse) l’episodio meno brillante del lotto, ricordo ancora con piacere diverse altre piccole gemme di un disco che in quei giorni letteralmente consumai: “Change”, “Deserted”, “Time” e “I Wonder” in particolare. Non esente da ingenuità dettate dall’entusiasmo e dalla baldanza, l’album si segnalava come una curiosa via di mezzo tra le istanze di rottura della scena dello stato di Washington e un rock delle radici d’impronta più chiaramente tradizionalista, un college-rock smaliziato con pur vaghe inflessioni sudiste (prima chitarra, basso e batteria erano, come detto, originari del Mississippi), andando a occupare una mattonella espressiva all’epoca ancora relativamente libera (se si ignorano i Soul Asylum) ma che di lì a poco sarebbe stata di fatto assediata, negli States come altrove (i più teatrali Live, Seven Mary Three, Collective Soul, Candlebox, For Squirrels, Lilys ma anche Wannadies e i Silverchair post-infatuazione da Cobain e soci).
Con oltre quattro milioni di copie vendute del loro esordio eponimo, i Blind Melon avevano fatto il botto. Seguì per loro un biennio di frenetica attività live e consolidamento, sempre a rimorchio di artisti ben più titolati: un’esperienza formativa importante, spesa condividendo il palco con il Lenny Kravitz di “Are You Gonna Go My Way”, con il Neil Young di “Sleep With Angels”, i Rolling Stones di “Voodoo Lounge” e poi, da fratelli, con gli Smashing Pumpkins di “Siamese Dream”, i Red Red Meat e i Porno For Pyros. I guai seri iniziarono in quel periodo, con un arresto per oltraggio al pudore (per avere orinato su un fan durante un concerto a Vancouver) e almeno un paio di ricoveri in riabilitazione da droghe per il cantante, uscito come trasformato anche nell’aspetto fisico: non più le lunghe chiome bionde e lisce, rimpiazzate da acconciature decisamente più drastiche, e immancabili apparizioni live con accorgimenti estetici inquietanti, su tutti il trucco pesante da panda a cerchiarne gli occhi (un po’ come il Richey Edwards – ancora lui! – dello stesso periodo). Fu abbastanza sconcertante, in tal senso, la partecipazione della band al festival del venticinquennale di Woodstock, nell’agosto del 1994. Sconcertante ma memorabile, proprio a causa, e insieme per merito, di un Hoon stralunato e visibilmente sotto effetto di acidi, presentatosi al pubblico con la voce lacerata, in una mise assurda (tunica bianca e sneakers, capelli agghindati con fermagli colorati) e autore di una prova tutt’altro che lucida ma commovente, per la visceralità e nel contempo la fragilità che rifletteva: un campanello d’allarme evidente, almeno letto a posteriori, che in pochi evidentemente colsero. Ci avrebbe provato il manager del quintetto, raccomandando a Shannon il sostegno di uno psicologo che venne però esonerato presto, vista l’incapacità di risolvere i cronici problemi di dipendenza del frontman.

Turbolenze a parte, fu una fase creativa febbrile per il gruppo, spostatosi a New Orleans per registrare al Kingsway Studio di Daniel Lanois un sophomore per forza di cose molto atteso. Prevedibilmente, i Melons avrebbero potuto limitarsi a tracopiare il canone del fortunato predecessore senza incassare recriminazioni di sorta e anzi, se possibile, consolidando ulteriormente l’alleanza con i network radiotelevisivi (emblematica la loro estemporanea cover di “Three Is A Magic Number”, dalla serie “Schoolhouse Rock!”, in seguito opzionata per la colonna sonora di una sfilza di commediole cretine tipo “Mai stata baciata” e “Tu, io e Dupree”). Decisero di prendere invece tutt’altra direzione, con un certo coraggio, anche se l’iniziativa non avrebbe pagato. Al loro fianco vollero Andy Wallace, già produttore di Rollins Band, Bad Religion e Faith No More, freschissimo di collaborazione con Jeff Buckley per l’indimenticabile “Grace” e respinsero ogni prescrizione dagli emissari della Capitol, di fatto inimicandosi la compagnia. Evidentemente ridestate dal clima culturale della Louisiana, le ascendenze sudiste di Roger Stevens, Brad Smith e Glen Graham conferirono ai nuovi brani un retrogusto ancora più verace e sanguigno, rilasciando nel contempo il guinzaglio alla spiritata verve del capobanda. Con Cobain morto e sepolto da un annetto e il punk-pop californiano di Green Day, Offspring e Rancid lanciato come nuovo fenomeno finto-alternative in vece degli stereotipati spettri grunge, i Blind Melon scelsero di sconfessare definitivamente quell’apparentamento a lungo mal sopportato e di reinventarsi nel segno di una radicale libertà espressiva e di un revival particolarmente sentito.
Ibridi rutilanti di hard-rock e funky rubacchiati all’amico Perry Farrell (“2×4”), ruvido e doloroso acid-rock affollato di fantasmi (come quello di Jackie Onassis in “Dumptruck”) o agghindato col vestitino easy-listening non senza il suo bravo velo d’inquietudine (“Galaxie”), confessioni di una mente pericolosa (il serial killer Ed Gein) tra humour nero e spigliatezza folk appalachiana (“Skinned”), frattaglie blues (“Wilt”), radiose elegie alt-country (“Vernie”, “Walk”), catatoniche ipotiposi zeppeliniane (“The Duke”), passaggi introspettivi spalancati su un baratro d’angoscia (“Toes Across The Floor”) e tirate nonsense con la bava alla bocca (“Lemonade”), il tutto incastonato entro una bislacca cornice dixieland appaltata a Kermit Ruffins e la sua Little Rascals Brass Band: quello di “Soup” era davvero il minestrone promesso dal titolo, acceso da sapori decisi, stridenti, e sufficientemente acre per non passare inosservato. D’altronde, quale altra formazione alt-rock del 1995 si sarebbe mai sognata di far risuonare in un proprio disco armonica, banjo (oggi inflazionato, ma all’epoca…), kazoo, violoncello, contrabbasso, fisarmonica, trombe, flauti e tuba? Loro sì, osarono. Una band maturata si trovava a dar fondo a tutte le proprie risorse di virtuosismo ed eccentricità, mettendosi completamente al servizio di uno Shannon ispirato come non mai.
Non ci sarebbero più stati filtri alle brutture, ai monologhi interiori chiamati a vomitare quasi con sadismo storie di dipendenze e abusi, alla faccia di quella stramaledetta, zuccherosissima, bambina obesa travestita da insetto; la morte sarebbe stata l’ospite d’onore, ma in una prospettiva adulta, una presenza da esorcizzare rituffandosi a capo chino nel proprio presente faticoso senza più dare nulla per scontato (“St. Andrew’s Fall”, che è un po’ la loro “A Day In The Life”) e, possibilmente, abbracciando ogni nuovo germoglio di vita come un’opportunità per tornare sulla retta via (la lisergica “New Life”, racconto della paternità imminente e, a conti fatti, di un’occasione rimasta solo sulla carta). Ma al tempo stesso ci sarebbe stato margine per la dolcezza, per le carezze acustiche, il ricordo da lacrime di una nonna generosa, e per più di un inciso estatico, dal duetto da brividi con l’esordiente Jena Kraus in “Mouthful Of Cavities” al sinuoso arabesco e lo spoken word liofilizzato del gioiellino “Car Seat”, così ambizioso da cannibalizzare una poesia scritta da un’antenata del cantante, Blanche Bridge, oltre un secolo prima. Il disco non si precludeva nulla in nome dell’appeal radiofonico, necessariamente sacrificato, e non ebbe alcun timore a presentarsi sotto una cappa atmosferica cupa e con un sound che, in aperta controtendenza rispetto alle ossessioni da lindore tecnico di quegli anni, abbracciava riverberi e impurità come autentiche benedizioni.
Con inettitudine e senza alcun imbarazzo, il critico di turno su Rolling Stone stroncò “Soup” perché “tradiva la band di No Rain”. Volersi evolvere rispetto ai canoni della propria canzone-mascotte diventava una colpa, non un merito. Nessun riferimento alla crescita dei cinque come musicisti e come autori, dopo trecento e passa concerti spesi fino all’ultima goccia di sudore, sera dopo sera, per migliorarsi. Il problema fu che alla Capitol la pensavano allo stesso modo e il disco non fu promosso quasi per niente. Le ultime apparizioni live del gruppo statunitense (emblematica questa per un programma televisivo, a un mese appena dall’epilogo) presentarono un Hoon rabbioso, intenso e luciferino, cartavetro nella laringe e mascara squagliato sotto gli occhi, amplificando le sinistre evocazioni già abbondantemente disseminate nei solchi dei due LP pubblicati. La strada, forse, era già segnata da tempo per un artista fragile e bipolare, ma è plausibile che delusione e disillusione abbiano avuto un ruolo nel lasciar precipitare gli eventi. Dopo un’ultima esibizione a quanto pare vissuta in stato confusionale, la mattina del ventuno ottobre del 1995, dunque, il frontman venne trovato privo di vita all’interno del tour bus. La morte, si sa, nel dorato mondo dello spettacolo vende sempre benissimo. Con Shannon Hoon, curiosamente , fece un’eccezione. Nessuno cavalcò la tragedia: non i compagni di viaggio, che da amici leali scelsero di mantenere un profilo basso e preferirono il rassegnato tramonto al cinismo degli opportunisti; non la Capitol, che da quel momento fece scendere l’oblio sui Blind Melon e si guardò bene dal pubblicizzare un album uscito in fondo soltanto un paio di mesi prima; non, infine, MTV e gli altri network, che rinunciarono in partenza alla ghiotta – dal loro punto di vista – occasione di promuovere a reti unificate un novello Kurt Cobain, evidentemente già troppo impegnati a trarre la massima resa da quel miracoloso feretro ancora caldo.
Così a Hoon fu risparmiato l’immancabile processo di deificazione, un po’ come sarebbe accaduto alla buonanima di Layne Staley, solo perché passato a miglior vita con troppo ritardo rispetto a quanto tutti si attendevano (e qualcuno sperava). “Soup” finì rapidamente nel dimenticatoio, così come il suo talentuoso, incredibile vocalist. I restanti Melons pubblicarono un’ultima raccolta, “Nico”, dedicata alla memoria dell’amico e alla di lui figliola, per la quale venne pure aperta una sottoscrizione benefica. Una manciata di demo, outtake e stramberie, pubblicate senza alcuna adulterazione produttiva in segno di rispetto nei confronti del cantante, utili a posteriori per moltiplicare a dismisura, più che altro, i rimpianti sul suo conto: buone cover da Steppenwolf (“The Pusher”) e John Lennon (“John Sinclair”), bozzetti dell’Hoon più intimo (“Life Ain’t So Shitty” e “All That I Need”), persino una filastrocca affidata da Shannon a una segreteria telefonica (“Letters From The Porcupine”) oltre alla prima canzone scritta in assoluto (“Soul One”), che la casa discografica riteneva una potenziale hit da knock-out tecnico e che loro si premurarono sempre, masochisticamente, di non far uscire mai, prima di allora.
E questo dovrebbe essere tutto, in pratica. Tralascio il poi, lo scioglimento e la reunion con nuovo frontman avvenuta una decina di anni dopo: è un’altra storia e una storia, per giunta, di cui proprio nulla mi interessa. A me restano i sedici anni cantati da Shannon in “I Wonder”, gli stessi sedici anni che avevo io quando comprai “Soup” e me ne innamorai, o quando Hoon scelse di congedarsi una volta per tutte privandomi di chissà quali e quante altre strepitose canzoni. Ecco, mi resta quel “What If…” grande come una casa e fa un male cane. Magari i Blind Melon sarebbero usciti dai radar in lenta dissolvenza, un passo falso dopo l’altro, magari no, chissà, avrebbero insistito con la strada più lunga imboccata per il difficile secondo album e sarebbero arrivati, alla fine.
Mi piace pensare che sarebbe andata proprio così: in fondo era esattamente quello che stavano facendo quando calò il sipario.