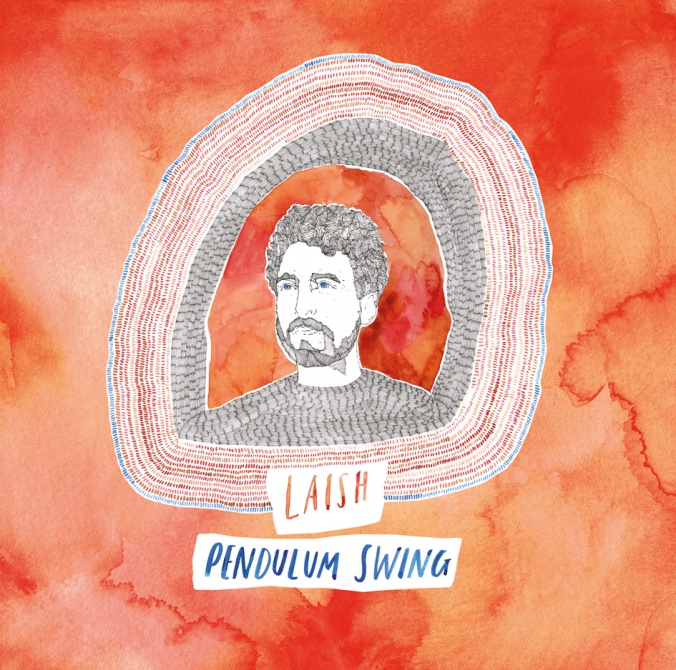Fool _Letture
Che stramaledetto spasso è farsi intrattenere da Christopher Moore! Quelli delle Edizioni Elliot lo hanno capito talmente bene che non si sono persi un titolo, se tralasciamo quel “Il Ritorno del Dio Coyote” edito da Sonzogno ormai una vita fa. Nella recensione che segue ho chiarito punto per punto perché questo pastiche sia irresistibile e compensi certi eccessi altrimenti ravvisati nell’autore statunitense, nel celebrato “Un Lavoro Sporco” ad esempio. Mentre divoravo entrambi i romanzetti non erano ancora usciti in Italia i rispettivi seguiti, “Il Serpente di Venezia” e “Anime di seconda mano”. Ci ha pensato la Elliott, come sempre, in tempi recenti. Sembrano promettere bene ma è difficile che sappiano entusiasmare come “Fool”, davvero Chris Moore al suo meglio.
Nel castello della Torre Bianca il vecchio re della fantomatica Britannia, Lear, ha deciso di farsi da parte e lasciare il regno a quella tra le sue eredi che mostri di amarlo con gli argomenti più convincenti. Tra le due figlie maggiori, le campionesse di perversione e crudeltà Goneril e Regan, è una bella sfida: con opportunismo da fuoriclasse, si servono delle lusinghe più spudoratamente false per gratificare il genitore, e il gioco paga. Non si abbassa al medesimo baratro di ipocrisia la più giovane Cordelia, che non nega all’anziano monarca lealtà e affetto ma nemmeno gli promette l’amore sopra ogni cosa, e per questo viene ripudiata, diseredata e costretta a un matrimonio senza dote con l’effemminato regnante di Francia. La partenza di quest’ultima, la messa al bando del più integerrimo dei cavalieri, il vecchio Conte di Kent, e l’esilio volontario del sovrano con un esiguo seguito di uomini in armi, spalanca di fatto le porte a foschi scenari e lotte intestine, con le sorelle pronte a strapparsi a vicenda l’altra metà del regno e l’infame figlio illegittimo del Conte di Glouchester, Edmund, pronto ad approfittare di una situazione generale non proprio trasparente per usurpare il titolo nobiliare e, se possibile, mettere le mani sulla corona dopo aver sedotto una a scelta tra le principesse fedifraghe.
Il solo ad aver intuito la gravità della situazione non è un nobiluomo, né un prelato o un magistrato, bensì il black fool, Taschino, il matto nerovestito, quella maliziosa e irriverente “sputacchiera di saliva ancora calda” che un po’ tutti a corte vorrebbero da tempo veder morto, forse perché la sua “finissima arte” sfugge regolarmente ai malcapitati bersagli della sua satira. Un po’ tutti, si diceva, tranne quei pochi che, in un modo o nell’altro, stanno appunto levando le tende. Anche a lui è riservata la medesima sorte, per fortuna, una temporanea fuga dal centro del pericolo, ideale per architettare con pochi fidati assistenti – l’amichevole apprendista minus habens Drool, il Conte di Kent ringalluzzito da un incantesimo, uno spettro in forma di fanciulla che dispensa enigmi in rima, una terna di streghe bonaccione, e il severo alter ego in miniatura Jones, picchiatore manifesto in stretta sinergia con la sua velenosa linguaccia – un ardito piano di riscossa che rimetta tutto a posto e regali all’ultima pagina il più scintillante degli “…e vissero felici e contenti”. Per la redenzione dei malvagi irrecuperabili, come per il riscatto di chi era marcio nonostante le apparenze, non ci sarà spazio ma l’amore, almeno quello, non potrà che trionfare.
E’ un Medioevo distopico ma incredibilmente attuale quello in cui si trovano a recitare – in certi frangenti, letteralmente – gli attori di “Fool”. Proprio come oggi ci sono due papi (uno “scontato” e uno “al dettaglio”) e il sesso è al centro di tutto, un’ossessione quotidiana declinata con gioiosa esuberanza, quasi come in una versione del Decamerone riveduta e corretta per restare al passo coi tempi. In quello che è un mirabolante minestrone di tòpoi shakespeariani – intrighi, sotterfugi, sensi di colpa, sprofondi a intermittenza nella pazzia, streghe e fantasmi, mutuati per ammissione dell’autore da una dozzina abbondante di opere del Bardo – Christopher Moore si prende la briga di riscoprire e nobilitare la figura del matto, da semplice dotazione o “divertimento ornamentale” di corte a metafora stessa di vitalismo e imprevedibilità, da cantastorie, giocoliere e diletto per infante (più o meno cresciute) a strumento del caso come nelle carte, il “numero zero” dei tarocchi che sfugge qualsivoglia categorizzazione e può rimettere ogni dettaglio in discussione, persino farsi motore dell’azione in un’esilarante black comedy e scatenare una guerra senza spade (ma con pugnali) e armate, con la sola forza dell’arguzia e di un bastone con la testa da giullare.
Moore è scrittore effervescente e pirotecnico come pochi, anche genuino con quel suo entusiasmo refrattario alle etichette e ai filtri di tanta letteratura di successo. Non sempre, tuttavia, i suoi pastiche pop grotteschi riescono gustosi e convincenti fino in fondo. Il deragliamento è eventualità sempre plausibile, il pericolo di indigestione kitsch molto più che concreto, per cui si rischia di ultimare la lettura dei suoi coloratissimi romanzi (uno per tutti, “Un Lavoro Sporco”) quantomeno provati dal bombardamento di rimandi alla cultura di massa. In “Fool” questo inconveniente è scongiurato dalla fluidità della sua penna, per una volta equilibrista con i fiocchi, e dalla felicissima maestria con cui questa piccola farsa è costruita e raccontata. Ma realmente cruciale, ancor più dei dialoghi efficacissimi o di una parodia che non si fa mai travolgere dall’amore viscerale per i suoi modelli, è il protagonista incontrastato. Lo scrittore statunitense è davvero sorprendente nell’animazione del suo genio fuori dalla lampada, incalzante nelle allusioni e salace negli affondi, ma sempre con una sottigliezza che gratifica e profuma d’intelligenza. Libertino, caustico, amarissimo: Taschino suona come una via di mezzo tra il Woody Allen migliore (quello anni settanta) e un buffone coprolalico e sessuomane à la Luttazzi dei bei tempi andati. Il bello, peraltro, è che non si esaurisce solo nella maschera comica. Supera lo stereotipo in agilità perché è figura umanissima con un triste passato alle spalle e, in barba ai connotati logori del matto, si muove nella storia con una lucidità che a tutti gli altri pare preclusa.
Un libro, insomma, divertentissimo. Il titolo ideale, forse, per chi voglia fare amicizia con Christopher Moore.
8.7/10