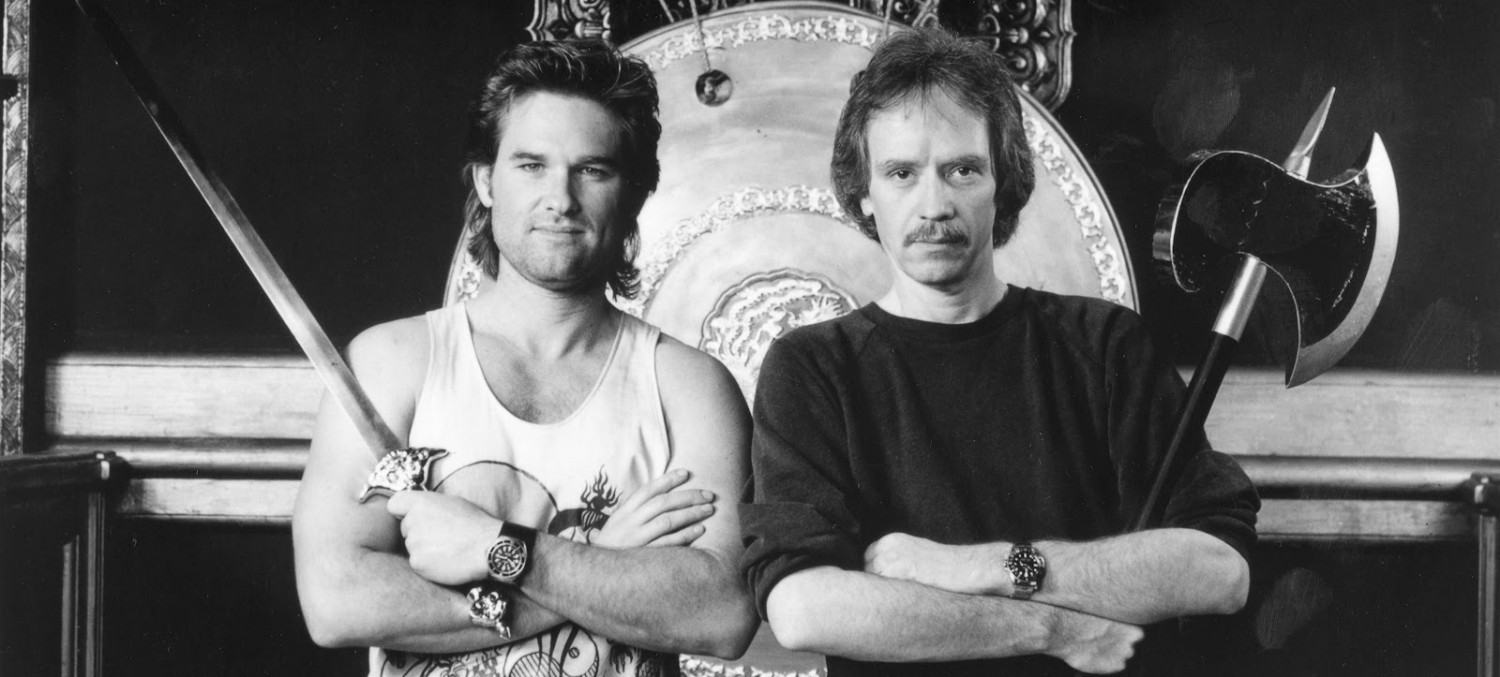L’Autunno a Pechino _Letture
Torno con immenso piacere a parlare di quel genio di Boris Vian. L’occasione mi è offerta dal recupero di uno dei suoi romanzi in assoluto più folli e pessimisti, “L’Autunno a Pechino”, salutato ormai cinquant’anni fa come il capolavoro dell’autore francese, stando a quelli della Rizzoli che si davano pena di promuoverlo. Con un rivale ingombrante come “La Schiuma dei Giorni” l’etichetta suona eccessiva, ma neanche poi troppo. Chiunque non abbia particolari problemi con il Vian più visionario e nichilista, quello dello “Strappacuore” per intenderci, in quest’opera rilanciata in tempi più recenti da Sellerio troverà pane per i suoi denti. Sembra un testo teatrale, anticipa il nonsense vertiginoso di un Richard Brautigan ed è un sublime lavoro poetico, un inno alla stupidità e all’inutilità che merita di non essere dimenticato.
Tra le dune della misteriosa Exopotamia è in programma la costruzione di una linea ferroviaria faraonica. Poco importa se si tratterà della più classica delle cattedrali nel deserto: il consiglio di amministrazione della società che in Francia si è assicurata l’appalto pare lanciatissimo, anche se nelle pompose riunioni dei suoi altissimi papaveri il clou è rappresentato dalla condivisione di cartoline pornografiche, e per le scelte operative si lascia molto alla buona sorte o all’immaginazione. Un direttore dei lavori, il pavido omosessuale Amadis Dudu, ha già avuto il suo bravo incarico; peccato sia giunto sul posto per puro caso, inconsapevole di quanto lo attendesse e condotto là da un autobus della linea 975 che non si capisce come abbia potuto attraversare mari e monti in una mezzoretta scarsa. Poco male, l’impatto con l’ambiente sembra corroborarne lo spirito e lo trasforma dal vessato per eccellenza nell’incubo di quelli che saranno i suoi sottoposti, giunti anch’essi nella desolata regione senza averlo programmato: Angel e Anne, due amici ingegneri entrambi di sesso maschile a dispetto del nome (“nome da cane”, scrive più volte l’autore), il secondo dei quali ha una fidanzata, Rochelle, platonicamente amata dal primo e qui presente in veste di segretaria; il professor Mangemanche, medico del cantiere che pare più interessato a dilettarsi con i suoi modellini d’aereo e a tormentare il suo assistente che non a esercitare con profitto la professione; il personale esecutivo, ovvero i nerboruti Carlo e Marin addetti al lavoro “di fatica”, con i rispettivi figlioli.
A tutti loro l’Exopotamia non sembra avere grandi svaghi da offrire, se si eccettuano alcune anomalie bizzarre (degne per inventiva, in futuro, di un Richard Brautigan) e la compagnia di pochi altri diavoli che vi si trovano imprigionati con serena accettazione: l’attempato archeologo Athanagore e il suo piccolo staff, con in testa la provocante “donna oggetto” Cuivre; la macchietta italiana Pippo Barrizone, proprietario tuttofare dell’unico albergo ristorante; il grottesco abate Petitjean e il suo protetto, l’eremita Claude Leon, riparato in Exopotamia dopo l’omicidio di un ciclista (con l’attenuante che si trattava di un conformista) per esercitare una forma di ascetismo non proprio ortodosso. Nella stasi e nell’apatia che l’ambiente regala in virtù della sua stessa conformazione geologica, il lettore è invitato a seguire il naufragare dei sogni dei pochi idealisti, assieme all’esplosione delle psicosi dei ben più numerosi (e disastrati) comprimari, mentre nulla di quanto programmato procede come dovrebbe, i binari vengono posati senza che una massicciata sia stata approntata e la morte si prepara a mietere il proprio raccolto, quasi con sollievo da parte delle annoiate vittime qui radunatesi.
“L’autunno a Pechino” è un’opera incredibile. Ha il suo stuolo di detrattori come è naturale che sia, trattandosi di narrativa pindarica e non particolarmente mansueta. Chi abbia già una certa familiarità con lo “stile Vian”, per aver affrontato in precedenza i ben più celebrati “La Schiuma dei Giorni” o “Lo Strappacuore”, non dovrebbe faticare a entrare in sintonia anche con questo testo, meno esplosivo in quanto a pirotecnia linguistica e fantastica, meno anarchico nella struttura, eppure di una buona spanna sopra la già ragguardevole media di cupezza e nichilismo dell’autore francese. L’avvio è folgorante. Un’autentica delizia nonsense, pura giocoleria dadaista, introduce uno alla volta i vari personaggi celebrando la poesia del contrattempo. Si fa “bu” agli orologi per mandare indietro le lancette e il giochino funziona, almeno per quella dei secondi; gli uccelli suonano col becco il tema de “I Battellieri del Volga”, ma steccano miseramente; le immagini riflesse nelle vetrine hanno il vizio di sgraffignare la merce esposta nei negozi; e le comuni sedie di legno possono essere operate e perire come qualunque paziente umano in sala operatoria. Terminata questa fase, il romanzo prende a normalizzarsi, a darsi un certo contegno formale, ma mai del tutto. Che senso avrebbe piazzare una ferrovia in un deserto, esattamente sopra un sito di scavi archeologici, e incaponirsi a farla passare proprio dove si trova l’unica costruzione già presente, costringendo all’esproprio coatto e a una demolizione dell’edificio ancor più demenziale in quanto incompleta? Nessuno, se si eccettua un’occasione d’oro per decantare la stupidità immortale di chi è al comando.
Non c’è dettaglio che non faccia pensare a un testo ideato per il teatro (dell’assurdo, si intende). I protagonisti in prima battuta, tutti tendenzialmente sgradevoli e fortemente caratterizzati come tristi caricature, che paiono palesarsi solo per recitare le loro battute sotto i nostri occhi; quindi la scena, desolante ancor prima che desolata, con un pugno di ambienti asettici e tristanzuoli. La struttura espressiva fortemente regolata e il ricorso massivo ai dialoghi non rappresentano tuttavia un limite, bensì un valore aggiunto: la lettura va infatti avanti che è una bellezza, nonostante l’umore saturnino che fa da padrone. Vi sono pagine realmente sublimi, tra le migliori mai scritte da Vian, come quelle del viaggio per mare visto attraverso gli occhi dei due ragazzini innamorati, Olive e Didiche. Il tono visionario, a rilascio graduale e molto ben disciplinato, è ancora una miniera di suggestioni, con lievità e armonia, “dolce come il canto del chiurlo fischione”. Certo come festa dei paradossi “L’Autunno a Pechino” non potrà che lasciare però l’amaro in bocca, visto che l’insensatezza ha rotto gli argini e ha intaccato senza più speranze ogni ambito, testuale e metatestuale (a cominciare dal titolo che, l’avrete capito, è del tutto gratuito, per continuare con le citazioni prive di significato piazzate in testa a ogni capitoletto): l’autore si riserva giusto poche comparsate esplicative o “passaggi”, che più che guidare demoliscono con pungente ironia le poche certezze rimaste a chi legge.
In fin dei conti si tratta di un inno all’inutilità, disincantato e folle quanto basta (come se Vian vi si fosse dedicato dopo essersi perso anche lui nelle porzioni di deserto delimitate dai raggi neri del matto sole exopotamico). Inutile è la vita, che con estrema leggerezza abbandona le spoglie di tanti di questi figuranti; inutile è il lavoro, che premia i parassiti e non produce nulla di utile o bello; inutili sono l’amore e le sue illusioni, ben rese dalla rivalità amore sacro / amor profano nello scontro senza vincitori tra Angel e Anne con l’insoddisfazione appostata dietro il primo angolo, pronta a avvelenare anche il cuore sulla carta più puro. Inservibili sono sia la religione, una scappatoia per i delinquenti, che la ragione, opportunamente affidate in chiave dissacrante ai due personaggi davvero indimenticabili del romanzo: il pretazzo crapulone e donnaiolo Petitjean, con i suoi rosari un tanto al chilo, il suo blocchetto di dispense autoassolutorie e quelle irresistibili filastrocche in vece delle più canoniche preghiere; e il medico Mangemanche, un macellaio in camicia gialla che al giuramento di Ippocrate ha preferito pericolose forme di rimbecillimento. La risposta è l’alienazione di chi sceglie di dimenticare. Come Athanagore, che recupera reperti integri e li distrugge. O come il consiglio di amministrazione, che insiste a perpetrare gli stessi errori a oltranza. In cima alle voci ormai inutilizzabili Vian colloca infatti la storia, quella con la esse maiuscola: costretta a ripetersi fatalmente con le sue tragedie e incapace di insegnare alcunché alle future generazioni. Un romanzo profondamente pessimista “L’autunno a Pechino”, a tratti eccezionale.
8.8/10