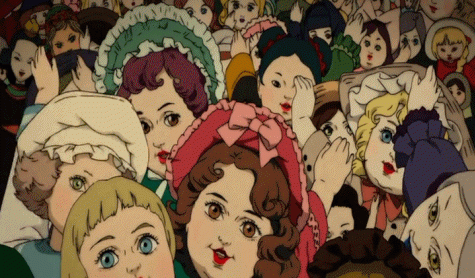Magic Kingdom _Letture
“Magic Kingdom” di Stanley Elkin era uno di quei romanzi che idealmente mi facevano l’occhiolino da tempo: collana “Minimum Classics” con il suo fascino innegabile, un plot pazzesco, il sodalizio Disneyland / morte che ha il suo perché. Come spesso capita quando le attese sono (magari irragionevolmente) elevate, la lettura si è rivelata una mezza delusione. Non perché la qualità manchi, visto che ironia e toni caustici sono espressi a buoni livelli, ma perché, boh, alla fine il risultato resta forse un tantino insipido, e le quattrocento e passa pagine non giustificano qualche brillante puntata nel grottesco. Una trascrizione filmica a opera di Wes Anderson potrebbe comunque essere grandiosa, chissà che non ci si arrivi prima o poi.
Nei quattro anni di malattia di suo figlio Liam, Eddy Bale si è affermato come il “mendicante più in vista e più famoso dell’intera Gran Bretagna”. Ha messo a durissima prova buongusto e senso del limite, racimolando cifre importanti, ottenendo un’insperata visibilità e spendendosi fino allo stremo delle forze per salvare la vita al bambino, massacrato dai medici di mezzo mondo anche se “con tutte le migliori intenzioni”. La morte del ragazzino dodicenne, offerta come il suo intero calvario alla cupidigia famelica del grande circo mediatico, ha di fatto annientato la sua famiglia, inducendo la scettica mogli Ginny a fare le valigie. Eddy tuttavia non si rassegna a una conclusione tanto amara e sceglie di consacrarsi anima e corpo a una nuova folle impresa, una missione di vita in aperto contrasto con le logiche di accanimento terapeutico che avevano consumato il povero Liam in maniera tanto disumana. Il progetto, apparentemente assurdo, consiste nell’organizzare un viaggio a Disneyland per un gruppo di sette giovanissimi affetti da malanni feroci e ormai giunti all’ultima spiaggia. Ancorché morbosa e sconclusionata, l’iniziativa ha successo anche grazie al modesto contributo iniziale di una Elisabetta di Windsor oltremodo glaciale. Bale seleziona personalmente un ristretto staff di collaboratori quasi “stesse scegliendo dei partigiani, una banda ben assortita per un colpo gobbo”, un manipolo di professionisti e “briganti del cuore”. Ne fanno parte l’infermiere omosessuale Colin Bible, già angelo umanissimo negli ultimi giorni del suo figlioletto; Nedra Carp, in passato tata dell’eroe delle Falkland, il principe Andrea; il dottor Moorhead, primario di pediatria più noto d’Inghilterra ma snobbato, incredibilmente, dagli alti papaveri quando sono in ballo inviti mondani od onorificenze di grido; e Mary Cottle, segretaria tabagista incapace di generare figli sani. Affidati alle loro cure, sette infelici che impareremo a distinguere più per la specifica sintomatologia dei loro morbi che non per effettive peculiarità caratteriali, eccezion fatta forse per l’esuberante Benny Maxine e il tenero Charles Mudd-Gaddis, di fatto un ottenne con l’Alzheimer e tutti gli acciacchi di un anziano con un piede e mezzo nella fossa. Come andrà a finire la loro avventura nel Regno Magico all’altro capo dell’Atlantico lo si intuirà presto, anche se i consuntivi, come è giusto che sia, saranno tracciati nel bel bagno di disincanto delle ultime pagine.
Sulla carta “Magic Kingdom” aveva tutto. Un soggetto pazzesco, tanto per cominciare, perfetto per saltabeccare a piacimento tra i registri del dramma e della farsa. Quindi i bambini, fattore di imprevedibilità narrativa per eccellenza. E ancora, un protagonista di quelli che tendono al memorabile, affiancato da un ristretto circolo di comprimari non meno degni. In ultimo, per l’edizione italiana (al solito impeccabile nei Classics di Minimum Fax), la benedizione urbi et orbi firmata da Rick Moody oltre a un più generale encomio sull’arte di Elkin, autore ancora colpevolmente invisibile nel nostro paese. Anche il fattore rischio poteva rientrare tra le variabili significative, una sorta di coefficiente di difficoltà aggiuntivo che appare inevitabile quando ci si veda costretti, nel trattare di minori attaccati dal cancro, a primeggiare in uno slalom gigante tra la melassa e le copiose lacrime di rito. Il libro riesce benissimo in quest’ultima prova, perché schiva a monte tutte le peggiori tentazioni della retorica sentimentalistica, perché è onesto nei confronti del lettore e ammirevole, anche, nel risparmiare i trucchetti da bassa macelleria di un cinismo oggi tanto in voga, à la Palahniuk per intenderci. L’atteggiamento di Elkin è distaccato e umano a un tempo, neutro e pietoso, una condotta che non conosce cedimenti nell’arco di circa quattrocento pagine e fa onore all’autore statunitense. Che cosa, allora, non funziona in questo romanzo? Beh, le altre premesse, quelle citate a inizio paragrafo, vanno perdendosi un po’ per volta, così che un senso di delusione non può che balenare, sottile ma inesorabile. Il protagonista, si diceva: Eddy Bale scompare a un certo punto, e riappare pallidissimo solo in chiusura, svuotato di ogni spessore, provato forse dal corso degli eventi e incapace – per volontà del suo creatore – di lasciarci morali più valide di un’inattesa scopata finale. I bambini, allora? Sono figurine non meno tiepide e impalpabili: anonime le tre ragazzine, che distinguiamo solo per i raccapriccianti segni esteriori della loro condanna; sfocati anche i maschietti, ridotti con le altre a un debole complemento oggetto, un sussulto psicologico assai poco incisivo, un’increspatura attanziale ideata in pura contrapposizione – d’innocenza candida ma imperfetta – allo squallore problematico del mondo dei più grandi.
E’ interessante come Elkin ami indugiare nel racconto di un autentico “groviglio di intenzioni, sentimenti e propositi asincroni”, ragioni complesse e prospettive contraddittorie. Il suo talento è tutto in questo sguardo quasi cinematografico (oggi diremmo in stile Todd Solondz, Paul Thomas Anderson o Noah Baumbach, solo che questo libro è arrivato almeno una dozzina di anni prima dei loro migliori film), mantenuto con un rigore persino prodigioso dall’inizio alla fine. Un tocco appena di ironia, che è sempre arma di classe, ma senza farsi prendere la mano rovinando la miscela. E’ geniale il contrasto di fondo, quello che anima e ingloba tutti i contrasti personali come un fuoco più ampio e potente: che i piccoli protagonisti si trovino a vivere la loro esperienza più reale in un mondo di fantasia e speranza, un parco a tema che sa di paradiso ma con una costante impressione di surrealtà, un senso di orientamento sempre distorto. La maggiore attrazione dell’Epcot Center è il “Mondo del Futuro”, e non può che suonare come una beffa per i giovani visitatori da tempo privati del loro domani; Pippo, Pluto e Topolino dovrebbero essere i meravigliosi compagni dell’infanzia, ma gli attori dietro le maschere sono individui meschini, e l’immagine riflessa sul soffitto di un ambiente buio li rende comunque terrorizzanti, non certo icone di un dolce conforto. Forse ha ragione Ginny, nella lettera scritta al marito e letta addirittura con un anno di ritardo: “non l’hai ancora capito che gli adulti sono molto più interessanti dei bambini?”. Stanley Elkin ci crede, ecco perché sceglie di sacrificare la sua carta vincente senza battere ciglio. I quattro “caratteristi” che accompagnano Eddy nella sua folle trasferta sono rispettosi ed equilibrati solo quando si tratta di salvare le apparenze, perché per il resto è il grottesco a scandire i loro disastrati retropalchi. Ecco quindi una tata ossessionata dal mito di Mary Poppins e da un passato di fantasmi incestuosi; un medico annientato dalla mania di grandezza che lo rende onnipotente, nell’illusione di poter indagare e prevedere ogni fenomeno clinico senza falle; un infermiere che nasconde le proprie insicurezze affettive sotto una corazza di praticità e gentilezza; e una donna condannata a ripudiare la propria femminilità e, al tempo stesso, incapace di liberarsi della propria enfasi masturbatoria come motore di una vita sconfinatamente triste.
Nessuna pietà per questi adulti che sono “meglio” dei bambini, anche perché e proprio con loro, e non con i secondi, che ci si può concedere di andar giù pesanti, senza remore. Nasce in questo impietoso affondo anche la consolazione di un libro per altri versi di lucida disperazione: non deve poi essere il peggiore dei mali perire da piccoli, se si ha sempre il conforto di una spiegazione logica (per chi crede di poterla trovare, comunque vada) a tutto, anche al male, al dolore, alla morte di creature che non hanno sbagliato. E solo, forse, perché non hanno ancora avuto modo di commetterli, i loro tragici errori. Il contentino dell’autore è quella sfilata paradossale offerta da Colin Bible ai sette ragazzini come alternativa al trito cerimoniale fiabesco del parco di divertimenti: quella galleria di uomini e donne sfatti, brutti, infelici e deprimenti, un rosario di esistenze scadute che a loro, almeno a loro, potranno essere risparmiate. Poco, tutto sommato, per riscattare le sorti di un romanzo che poteva essere memorabile ma non lo è quasi mai. Che procede freddo per la sua strada, crudele e impassibile in una distanza che al lettore non è dato modo di riassorbire. E che pecca continuamente di prolissità, vanificando una scrittura anche eccellente e brillante. Frasi e periodi troppo lunghi, persino angoscianti, trattini che aprono diramazioni del senso, che inglobano e fagocitano altre riflessioni, con dentro suggestioni che hanno dentro altre riflessioni, fino a perdersi. Spiace, perché “Magic Kingdom” rende perfettamente l’idea di quanto fosse intelligente e caustico Elkin, di quanto la sua arte e il suo sguardo si mantenessero ben fuori da un sentire e un narrare ordinari. Un vero peccato che il romanzo non sia stato al passo con le sue premesse: poteva uscirne qualcosa di epocale, ma non è questo il caso.
6.8/10