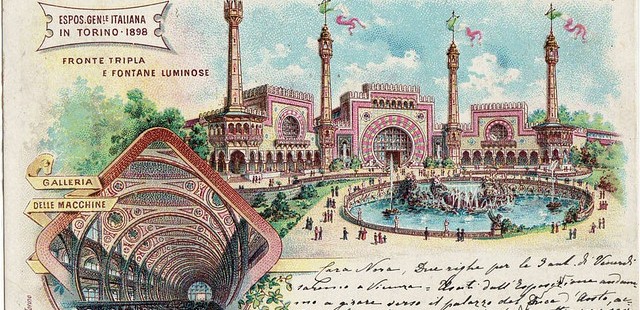Il Nazista e il Barbiere _Letture
Riecco Edgar Hilsenrath! Come?
Non avete la più pallida idea di chi sia? Male, evidentemente non siete stati attenti quando magnificavo uno dei più bei romanzi letti in vita mia. Questa “favola nera sul conformismo” si è rivelata un controverso best seller, a lungo temuto per le sue scomode verità in patria. Più poesia espressionista che crudo realismo comunque, per un romanzo a tema che paga qualcosa in termini di didascalicità solo nelle battute conclusive, ma per il resto affascina con sublime ironia e più di un lampo visionario, contribuendo a fare di Hilsenrath un autore magari parsimonioso ma abbastanza imperdibile
Germania orientale, anni venti: Max Schulz è l’ultimo tra i reietti nella zona ebraica della cittadina di Wieshalle (nome di fantasia). Figlio di una prostituta e di non si sa bene quale padre (cinque gli “indiziati”), brutto come la fame, vessato e abusato già in tenerissima età dall’orribile patrigno Slavitzki – un barbiere di terz’ordine – cresce lontano dalla grazia abitando i peggiori scantinati possibili, in un clima di rancore strisciante, vuoto affettivo e miseria culturale. Nel decennio turbolento che condurrà all’affermazione di Hitler, periodo in cui il risentimento popolare per la sconfitta nella Grande Guerra e un’inflazione galoppante saranno pretesti scientemente cavalcati per alimentare l’odio verso gli ebrei, lui, ariano dai caricaturali tratti semitici, trova l’unico conforto a un’esistenza sventurata proprio nell’amicizia di un’agiata famiglia di borghesi ebrei, i Finkelstein: il giovane Itzig, nato il suo stesso giorno ma, a differenza di lui, bello, biondo e con gli occhi azzurri, che lo incoraggia negli studi, gli insegna l’yiddish, le preghiere e i riti del popolo eletto; e il padre di questi, Chaim, che lo introduce al mestiere di barbiere e gli offre un posto di lavoro nel suo elegante salone, “L’Uomo di Mondo”. Seppur osteggiata dai suoi congiunti, la possibilità di un virtuoso riscatto sociale e umano sembra realmente a portata di mano. Ad annientarla sarà però l’ascesa al potere del Nazionalsocialismo, abbracciata a sorpresa da Max con la viltà tipica di tanti suoi connazionali: non certo per chissà quale convinzione antisemita, quanto per l’opportunismo di chi, a lungo roso dall’invidia, ha scorto nelle nuove deliranti istanze politiche la classica “via più breve” per il compimento della propria scellerata fame di rivalsa. In una rapida sequenza di pagine che sembrano un unico assurdo incubo, ecco trasformarsi il nostro protagonista da occasionale testimone delle prime adunate hitleriane, gomito a gomito con il suo stesso carnefice di un tempo, dapprima in un fervente col vizietto della violenza gratuita, quindi in un efferato e rigorosissimo strumento di morte col distintivo di ferro delle Schutzstaffel appuntato sul petto.
Con la stessa gelida impassibilità a guidarlo, lo ritroviamo – nei resoconti che lui stesso ci offre – mentre veste i panni dell’affidabile addetto alle esecuzioni di massa, in villaggi dell’est Europa prima, e in un campo di sterminio polacco poi (Laubwalde, altro nome di fantasia) dove, tra le decine di migliaia di vittime mietute per mano sua, cadranno anche l’amico di gioventù – liquidato alle spalle alla maniera dei vigliacchi, senza neppure il coraggio di guardarlo negli occhi – e quella coppia di coniugi generosi che lo avevano sempre trattato come un secondo figlio. Quando l’inerzia della guerra svolta, Max Schulz inizia una fuga rocambolesca dai territori ora occupati dall’armata rossa, portando con sé una scatola di denti d’oro strappati ai morti nel campo. Scampato a un agguato partigiano nella gelida campagna polacca, riuscirà a trovare un nascondiglio per l’inverno nella dimora di una vecchia sadica, prima di riparare a Warthenau e poi a Berlino. Qui il raccapricciante colpo di genio per scampare ai tribunali e alla giusta condanna al patibolo: farsi circoncidere, farsi tatuare sul braccio il classico codice numerico dei deportati e assumere l’identità di quel compagno di giochi, studi e lavoro, da lui stesso trucidato. Sembra la più paradossale e cinica delle soluzioni, e lo stesso criminale di guerra non ha idea di quanto a lungo possa stare in piedi, una simile farsa. Eppure nel caos postbellico, il buco nero della documentazione sulla Shoah rivela l’efficacia di questo espediente, e il perverso nazista dagli “occhi di rospo” costruisce anche una discreta fortuna grazie al mercato nero (e all’oro trafugato, naturalmente). Per assicurarsi il rispetto dei potenti si lascia umiliare e buggerare da una contessa antisemita, ma i torti e il disprezzo patiti in prima persona cominciano ad avere effetti imprevisti su quel che resta della sua coscienza: l’immedesimazione si compie, Max diventa Itzig e sposa la causa sionista con convinzione: ormai più realista del re, si imbarca per la Palestina, si schiera con i terroristi contro le truppe inglesi, combatte nell’Haganah e diventa un eroe del neonato stato di Israele, prima di regalarsi un felice vespro dorato, un salone da barbiere chiamato non a caso “L’Uomo di Mondo”, una moglie vittima di eccidi di cui forse è responsabile e quella serenità così a lungo agognata. Per il pentimento e l’espiazione però, beffa delle beffe, non ci sarà margine, se persino la sua tardiva confessione a un giudice in pensione verrà scambiata per demenza senile.
“Il Nazista e Il Barbiere” è un romanzo allucinante. Non particolarmente cruento, non feroce nei riguardi del lettore, per come racconti le mostruosità della persecuzione nazista verso gli ebrei. Edgar Hilsenrath, vittima in prima persona di una deportazione in un ghetto romeno, tiene il campionario delle atrocità fuori dalla nostra portata, oppure scherma quel poco che sceglie di non risparmiarci attraverso un filtro narrativo che tende allo straniamento, alla deformazione surrealista, e che conferisce alle vicende un inquietante alone onirico limitandosi all’allusione, all’accenno furtivo, e rinunciando all’orrore nudo e crudo. La natura paradossale ma nemmeno poi così incredibile – almeno guardando al contesto di riferimento – della sua storia non rimuove tuttavia (e se possibile amplifica) quel senso di raccapriccio, di amoralità disturbante che l’indimenticabile doppio protagonista del libro incarna in maniera tanto potente. Dietro il velo scuro di un’ironia di grana finissima, dispensata senza mai indulgere nel patetismo o in forzature di comodo, si può cogliere un atto di accusa impietoso nei confronti di un’intera nazione, succube della follia nazista più per tornaconto che per pura ideologia. Spiace che un’opera scritta nel 1968 e subito baciata dal successo in mezzo mondo abbia dovuto patire il rifiuto di ben venticinque editori prima di essere pubblicata anche in patria, con l’incredibile ritardo di un decennio o giù di lì, ma è evidente che questo testo arrivava a toccare un nervo scoperto in Germania e destò non poco imbarazzo. Questo spiega anche perché un autore eccezionale come Hilsenrath, da sempre impegnato a raccontare con eleganza “fiabesca” quello ebraico e altri olocausti (“La Fiaba dell’Ultimo Pensiero”, dedicato al genocidio degli armeni da parte dei turchi, resta con ogni probabilità il suo capolavoro), non abbia mai goduto dalle sue parti della considerazione che avrebbe meritato. L’assunto, in fin dei conti è quello di sempre, incontrato più e più volte nelle testimonianze dei criminali nazisti: c’erano gli ordini e si obbediva. Così almeno si giustifica a più riprese, tra le pieghe del suo torrenziale monologo interiore (interrotto solo nel secondo dei quattro libri, per tratteggiare in terza persona la trasfigurazione del carnefice nella vittima), il vile Max, parlando di sé come di “un pesce piccolo che seguiva solo la corrente”.
Più che una riflessione sulla Storia, la sua parabola di mirabolante e inverosimile trasformismo a caccia di un’identità rispettabile (e trionfante) pare una disquisizione sulla sconcertante banalità del male (per dirla con Hannah Arendt), sulla seraficità di chi lo sposa in silenzio per puro calcolo e vi si adagia poco alla volta. Quella di Hilsenrath è più che altro una spaventosa favola nera sul conformismo, protagonista uno Zelig a tal punto persuaso della propria innocenza da non saper suscitare nel lettore neanche una particolare antipatia. Al suo posto, gli spiazzamenti del registro grottesco, il turbamento che si prova al cospetto di un assassino stragista che sembra guidato più dalla noia e da un generico desiderio di rivalsa che non dall’odio vero e proprio; un mostro che parla di sé definendosi candidamente idealista, “uno di quelli che vanno dove tira il vento”, che si schierano per deformazione dalla parte dei vincitori e nel loro lucido, impassibile opportunismo, fanno ancora più paura. Muovendosi con lievità tra poesia e espressionismo, la prosa del narratore fa il resto e compie ancora una volta un mezzo miracolo di equilibrismo. Mezzo, solo perché a una prima parte favolosa ne corrisponde una seconda per forza di cose più didascalica, funzionale in chiave programmatica, anche al costo di sacrificare quell’alone di magia grazie al quale le disavventure del nazista in fuga avevano imbonito per bene il lettore. Tante le pagine memorabili, ma quelle sulla prigionia dell’ex uber-mensch nelle grinfie della vecchia strega ninfomane Veronja restano inarrivabili.
8.2/10