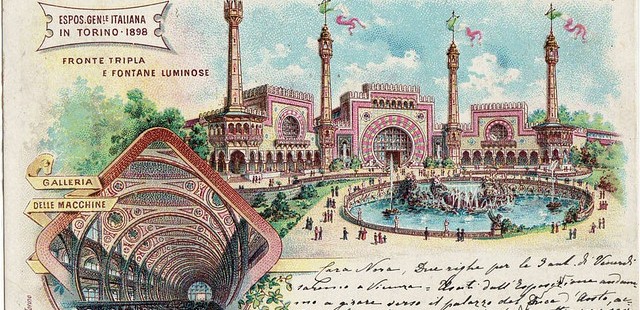I once fell in love with you
just because the sky
turned from grey into blue
Una favola raccontata fino allo sfinimento può sbiadire.
Se le fandonie si consolidano replica dopo replica, così da riciclarsi in verità anabolizzate, la parabola imbevuta di magia allo stesso peso del piombo rischia di sfarinarsi in una sterile processione di parole, e amen.
Di troppo incanto ci si ammala.
Chi lo accoglie con scetticismo può soffrire d’invidia, chi lo emana senza criterio è quasi condannato a dissiparlo. Così almeno è capitato alle sorelle Sierra e Bianca Casady – i nomignoli Rosie e Coco direttamente nel nostro apologo dal cuore di mamma – estro puro nel dilapidare un patrimonio di meraviglia pressoché sterminato.
Una vicenda, la loro, della quale era difficile non innamorarsi. Separate giovanissime dopo un’infanzia raminga in compagnia della madre, layered drink di sangue siriano e cherokee, le estati trascorse alla mercé di un padre scopertosi hippie con qualche lustro di ritardo, sballottate tra questa e quella riserva indiana alla ricerca di rivelazioni sciamaniche che sarebbero giunte, notevole opportunismo, solo nei giorni della loro bieca rivincita imprenditoriale. Quindi l’ellissi durata quasi dieci anni: Sierra a Parigi con sogni da soprano, Bianca intenta a prorogare a oltranza il suo ondivago presente di scapestrata fuoricorso. E poi quel ritrovarsi nemmeno preventivato in un appartamento a Montmartre, terribile estate canicolare 2003, con la promessa di non dividersi più. Quel disco partorito per gioco nella vasca da bagno quasi fosse un figlio indesiderato, in fondo, primo vagito dei loro talenti sin lì celati a chiunque. Sorelle e madri e levatrici le Cocorosie, l’una per l’altra, incapaci di custodire il segreto più a lungo d’un batter d’ali. Il nastro nelle mani dell’amico giusto valse l’imbucata in coda all’ultimo convoglio dell’espresso truffa, il famigerato prewar-folk, nel suo tragitto inaugurale e conclusivo su uno splendente binario morto. A legittimare l’apparentamento furono sufficienti la chitarra di Sierra, affogata senza sadismi nella bassa fedeltà che ai tempi vendeva ancora assai bene, oltre a quell’irresistibile weirdness ludica, fotografia fedele e insieme segno particolare sul documento d’identità del duo.
Si trattò di un miracolo autentico, di quelli che baciano in fronte i principianti mentre attorno è tutto un sollazzo. Imbandito senza star troppo lì a favellare, offrendo l’intera esclusiva alla propria amatoriale e sconfinata stravaganza. Proto-beat pulciosi, chincaglieria assortita, campionamenti da battaglia, strumenti giocattolo possibilmente rotti o scordati, effrazioni gospel e l’immancabile pizzico di pseudofilosofia, molto ben smerciata nel loro caso. Fu allora che le incrociammo in un piccolo caffè in centro città, passaparola carbonaro ormai prossimo a lasciare il campo alla gloria internettiana con i relativi crismi, elettricità da infatuazione sospesa nell’aria e volti ancora quasi puliti: appena una lacrima posticcia su quello di Sierra, e baffetti alla Dalì per una Bianca già stregata dal suo bel Devendra.
Momento irripetibile.
Non durò, infatti. Infastidita dal genio elusivo di chi non vuol saperne di lasciarsi blindare da un’etichetta, innervosita dal suo stesso irrazionale entusiasmo della prima ora, la critica promise di sconfessare quello che andava per forza ripensato come un equivoco e giurò loro vendetta. La schizofrenia degli imbrattacarte, occorre dirlo, contagiò in negativo anche le sorelline venute dagli States. Troppo fragili, quando per eccessiva ingenuità si limitarono a tracopiare le linee variopinte dell’esordio e vennero messe in croce per l’innocuo cattivo gusto di una copertina. O troppo spavalde, quando al giro successivo confusero presunzione e coraggio inzaccherando con una certa strafottenza alcuni validi spunti nel peggior pantano break-beat, jungle o trip-hop. Drogate dal bisogno di stupire sempre e comunque, attente al mood e a un esotismo atrocemente artefatto, maniache dello stile per lo stile e distratte da una miriade di stimoli extramusicali, le Cocorosie si sono trasformate in una macchina da guerra pacchiana, quando non grottesca, capro espiatorio perfetto per gli spacciatori d’hype con troppe tardive riserve sul loro conto. Il risultato? Album massacrati ben al di là degli effettivi demeriti, antipatia rimarcata con enfasi crudele, e un circo barnum a rimorchio sempre più avaro di emozioni sincere. Incontrate dopo anni sul cammino, abbiamo dubitato seriamente delle nostre facoltà nel ricordare. Fattucchiere da strapazzo invece delle fate d’un tempo, una triste idea di teatro spacciata per arte a zavorrarle in scena, e tutta la poesia di ieri come dispersa, evaporata.
Le avremmo dimenticate volentieri come ogni bella storia finita male. Con il superfluo corollario dell’inevitabile linea di moda, il make-up osceno delle ultime incursioni o l’avant-pop collaterale dei trascurabili Metallic Falcons, non fosse intervenuto a dissuaderci questo nuovo ‘Tales of Grass Widow’, il disco meno temerario e arrogante di tutta la loro carriera. Gli sconsiderati che delle Casady avevano venerato più di tutto quell’involuzione paurosa ora storcono il naso. Noi che le guardavamo con simpatia all’inizio, accenniamo un sorriso. Bentornata gentilezza, possiamo dirlo. Di tutte le strambe ideazioni affastellate negli anni per raggranellare altri denari dai fanatici gonzi, l’unico estraneo a scopi lucrosi – il collettivo Future Feminists – sembra esser stato il più sensato. Quest’album nasce come implicito megafono alla sua mission. “Dalla parte delle bambine”, avrebbe potuto esserne il sottotitolo, come il celebre saggio di una grande pedagogista italiana. E a guardar bene, di un pur anomalo concept si tratta, indagine sulla solitudine delle più deboli tra i deboli, vittime di abusi in contesti retrogradi obbligate ad aggrapparsi con disperazione a una realtà trasfigurata per necessità. Protagoniste tante piccole, cresciute come loro con la sola stella polare di una prospettiva escapista. Così la sposa di cinque anni che si consola guardando crescere libera l’erba fuori dalla sua finestra, così la bimba rinfrancata dalla compagnia dello sparviero o la ragazzina che affida all’anziana necrofora il suo amore negato, affinché sia custodito in santa pace dalla terra. Un filo conduttore forte, quindi, che ha costretto Coco e Rosie a disfarsi dell’estremismo da galleria d’arte per perseguire il fine a lungo trascurato della leggerezza.
Torna in auge il registro fiabesco ed è un porto sicuro, al pari dell’ennesima ospitata strappacuori per l’usignolo Antony, una Madre Natura buona e opulenta questa volta. Le suggestioni si assottigliano. Le atmosfere in sottofondo guadagnano crediti. Non di rado le sollecitazioni rasentano il glitch-pop e accarezzano l’epidermide senza graffiarla. Non hanno rinunciato al loro mentore islandese Valgeir Sigurðsson le Cocorosie, né alla smisurata dotazione di cliché adoperati con lui quando registrarono il controverso “The Adventures of Ghosthorse and Stillborn”: il tono mesto del pianoforte, i gorgoglii sintetici, i bjorkismi di Bianca e le velleità da melomane di Sierra. Il tutto è gestito con quel polso che all’epoca era mancato e che ora rende gradevole persino il romanticismo affettato nella malmostosa interpretazione della più giovane, evidentemente qualcosa di inestirpabile. I contrasti rimangono il loro pane, e lo stesso vale per la destrezza nel proporre refrain tanto elementari quanto micidiali. Poi certo, se i ghirigori celestiali di Rosie saranno traviati dal consueto pastone rap di Coco o dal pencolante rumorismo dell’amico Tez, non si potrà che concludere che è sempre di kitsch che si sta parlando, e non potrebbe essere altrimenti. Ma la misura nel pastiche stavolta è corretta, l’amalgama funziona, le frattaglie elettroniche non prevaricano come bulli di rione e le smargiassate restano un ricordo da mettere sotto teca, da affidare all’oblio di una ghost track tenuta opportunamente fuori mano. La voce adulta di Sierra e quella da bimbetta capricciosa di Bianca, due anime che tornano a fondersi in maniera armonica. Incontro e non scontro, voglia di far breccia con l’intatta naturalezza di quel torrido agosto in un bagno parigino. Il cielo che aveva fatto incupire perfino gli oceani, suoi pazienti dirimpettai, sembra disperatamente bisognoso di ritrovare la gaiezza luminosa del suo colore perduto.
La buona notizia, per noi, è che forse torneremo presto ad innamorarci.